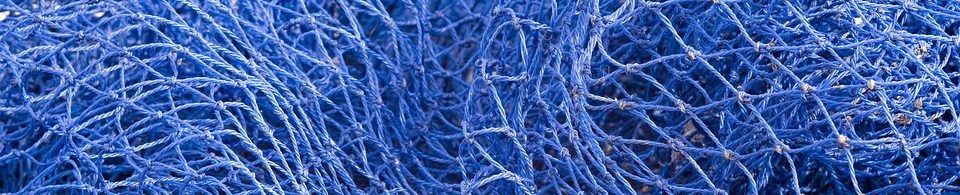I SUONI DELLE LETTERE SECONDO PLATONE di Letizia Gariglio
Di tanto in tanto Grazia Valente ed io ci divertiamo a giocare con i suoni, lasciandoci trasportare dalle nostre sensazioni o da alcune riflessioni in proposito. Ma oggi la prendo un po’ più sul serio, e vado a giocare nientemeno che con Platone, che si è dibattuto sulla possibile opposizione fra motivazioni e arbitrarietà riscontrabili nelle origini dei linguaggio. Nel Cratilo affida al personaggio omonimo la parte del sostenitore della prima ipotesi, e a Ermogene la tesi dell’arbitrarietà. Fin dall’inizio Socrate viene invitato a partecipare alla discussione.
Cratilo in sintesi afferma ( è Ermogene a riferirlo) «che ciascun essere possiede il nome corretto che per natura gli conviene»; invita dunque Socrate ad esprimere il proprio parere sull’argomento, e Socrate dichiara di non sapere quale sia la verità a tale riguardo ma di essere pronto a ricercare la risposta insieme a Cratilo e ad Ermogene. In realtà fin da subito la conversazione tende a snodarsi fra Socrate ed Ermogene, Cratilo “rientrerà in scena” solo più avanti.
Particolarmente interessante è il passaggio in cui Ermogene afferma che sono coloro che inventano e adoperano gli strumenti ( per esempio la spola o il trapano), che, allo stesso modo con cui attuano il processo di ideazione e di costruzione dell’oggetto, appongono i nomi: saranno questi artigiani ad apporre i nomi, non per mezzo del loro estro o del loro capriccio, ma sulla base della loro arte specifica e della capacità di svolgere l’attività con quegli strumenti. Essi saranno i legislatori.
Platone si impastoia, per bocca di Socrate, in improbabili ricostruzioni etimologiche (che hanno un che di favolistico), assai poco convincenti (sui quali ora non mi soffermerò), ma infine, messo in difficoltà da Ermogene, entra nei particolari dei fonemi, i quali esprimono l’essenza nella loro stessa capacità di imitare il significato.
Così ci spiega che la stessa articolazione dei suoni, operata con tutti i muscoli occorrenti all’operazione, producono una forma di gestualità, che rispecchia quella corporea, ma che rimanda direttamente alle qualità acustiche dei fonemi. Inoltre i suoni possiedono specifiche qualità acustiche. Nell’ambito del Cratilo dunque individua alcune equivalenze fra suoni e simboli.
Nel“ro” individua lo strumento per esprimere il senso del movimento: «La lettera “ro” parve essere un bello strumento di moto a colui che poneva i nomi (il legislatore) per rappresentare il concetto di “phora” (cioè movimento) e assai spesso dunque se ne è avvalso per questo fine». Cita poi una serie di nomi contenenti il suono “ro”, come “tromo”, (tremito), “trechein” (correre), “ereichein” (fendere), krouoein (percuotere), trhauein (rompere), e altri ancora.
Quanto allo “iota”, dice, «si è avvalso per tutto ciò che è minuto e può andare dappertutto».
Sul “delta” e il “tau “ dice: «La forza del“delta” e del “tau” deriva dalla compressione e dall’appoggio delle lingua, pare che egli la consideri utile all’imitazione del legame e della sosta.
«Accortosi che la lingua sdrucciola particolarmente nel “lambda”, per assimilazione chiamò le cose lisce “leia” e nominò lo stesso «olisthanein”(sdrucciolare) e “liparon” (untuoso) e “kollodes”, (vischioso).
Quanto al suono “gl”: «Siccome quando la lingua scivola, le fa resistenza la forza del gamma, imitò con esso il “gliskhron”(vischioso), il “glyky” (dolce) e il “gliodes” (viscido)».
«Avvertendo poi nel “ni” un suono che rimane all’interno della voce diede il nome a che è “endon” (interno )e “enthos” (dentro) come per dare immagine alle cose con le lettere.
«E ancora attribuì l’”alfa” alla grandezza e l’”eta” alla lunghezza.
Infine, avendo bisogno di un segno “o” per ciò che è tondo, lo mescolò moltissimo a questo nome».
Genette definiva Platone come un cratilista deluso, costretto a rinunciare, in certo qual modo, alla teoria della giustezza dei nomi, sebbene auspicasse la prevalenza della motivazione contro quella dell’arbitrarietà.