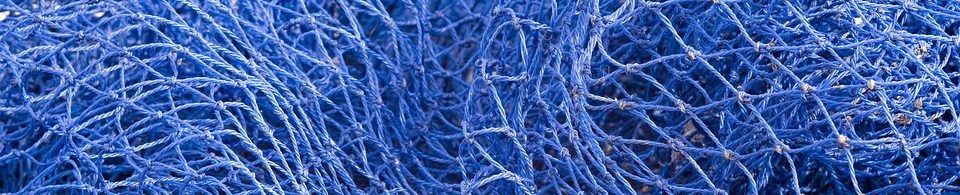DANTE SPEZIALE NEL PURGATORIO di Letizia Gariglio
È soprattutto nel Purgatorio che vengono nominate piante e fiori, fin dal Primo Canto, quando Catone ordina a. Virgilio di cingere i fianchi di Dante con un giunco (simbolo di umiltà) che cresce nella parte più bassa dell’isola, e di lavargli il viso, affinché si presenti pulito dalla caligine infernale di fronte all’Angelo che sta di guardia al Purgatorio. Così viene fatto. (Purgatorio, I, 94 e seguenti):
«Va, e fa che tu costui ricinghe
d’un giunco schietto e che li lavi ‘l viso,
sì ch’ogni sucidume quindi stringhe…»
L’ulivo trova posto in Purgatorio, (II ,67 75.) L’ulivo è metafora per indicare le buone notizie. Le anime si accorgono che Dante è vivo, respira, e gli si fanno attorno come a un messaggero che porta l’ulivo, simbolo di pace:
«E come a messagger che porta ulivo
tragge la gente per udir novelle,
e di calcar, nessun si mostra schivo,
così al viso mio s’affisar quelle
anime fortunate tutte quante,
quasi obliando, d’ire a farsi belle».
Sempre nel Purgatorio (II, 124-126) ad un certo punto Catone, nella sua severa figura, sgrida le anime che si sono perse ad ascoltare la canzone di Casella, e le sprona ad abbandonare l’indugio e a spogliarsi dalla scorza di peccati. Così loro fanno, come i colombi che abbandonano per un moto di paura la biada e il loglio:
«…”Che è ciò, spiriti lenti?
Qual negligenza, quale stare è questo?
Correte al monte a spogliarvi lo scoglio
ch’esser non lascia a voi Dio manifesto”.
Come quando, cogliendo biada o loglio
li colombi adunati alla pastura,
queti, senza mostrar l’usato orgoglio,
se cosa appare ond’elli abbian paura,
subitamente lasciano star l’esca,
perch’assaliti son da maggior cura…»
Ma il loglio sarà citato anche in Paradiso (XII,118-120).
In Purgatorio (IV, 19-23) paragona un passaggio stretto in cui devono passare ai varchi nelle siepi di recinzione, che i vignaioli cercano di chiudere con dei rami spinosi per proteggere le uve dalle tentazione dei ladri:
«Maggiore aperta molte vuole impruna
con una forcella di sue spine
l’uom della villa quando l’uva imbruna…»
Nel Canto XVI al verso 115 dice che: «ogni erba si conosce per lo seme».
Dante cita il mirto quando in Purgatorio, (XXI,88 92), incontra il poeta Stazio, che dice di aver meritato «le tempie ornar di mirto»:
«Tanto fu dolce mio vocale spirto,
che, tolosano, a sé mi trasse Roma,
dove meritai le tempie ornar di mirto»
Nel Canto XXII giungono sul ripiano della sesta cornice; ad un certo punto appare un albero carico di buoni frutti che, all’opposto dell’abete, ha rami più corti in basso e più lunghi in alto, perché nessuno possa salire: è uno strumento punitivo per i golosi. Ecco i versi (130- 135):
«Ma tosto ruppe le dolci ragioni
un alber che trovammo in mezza strada,
con pomi a odorar soavi e boni;
e come abete in alto si digrada
di ramo in ramo, così quello in giusto
credo, perché persona su non vada.
Nel Purgatorio (XXVII, 31 42) parla del gelso vermiglio. Piramo e Tisbe nel mito muoiono insieme presso un gelso. Il gelso, che era stato intriso dal sangue di Priamo, mutò il colore dei suoi frutti, che da bianchi divennero vermigli:
«Come al nome di Tisbe aperse il ciglio
Piramo in su la morte, e riguardosa,
allor che ‘l gelso diventò vermiglio….
In Purgatorio (XXVIII, 7 21) Dante si dirige verso la campagna, che emana gradevoli profumi. È desideroso di visitare l’Eden. Spira una dolce aria che passa fra le chiome degli alberi e ne percorre le fronde, senza tuttavia impedire agli uccelli di cantare, accompagnati dallo stesso venticello, come nella pineta di Classe, quando soffia lo scirocco:
«Un’aura dolce, senza mutamento
Avere in sé, mi ferìa per la fronte
non di più colpo che soave vento;
per cui le fronde, tremolando, pronte
tutte quante piegavano alla parte
U’ la prim’ombra gitta ‘l santo monte;
Non però dal loro essere dritto sparte
tanto, che li augelletti per le cime
lasciassero d’operare ogni loro arte;
ma con piena letizia le ore prime,
cantando, ricevendo intra le foglie,
che teneva bordone alle sue rime,
tal qual di ramo in ramo si raccoglie
per la pineta in su ‘l lito di Chiassi,
quand’Eolo Scirocco fuor discioglie».
Il Canto XXXII del Purgatorio è il canto della «pianta dispogliata». Tutti i presenti alla scena si dispongono attorno a una pianta priva di foglie e di fiori. Essa ha la particolarità di avere rami sempre più larghi a mano a mano che si eleva verso il cielo, contrariamente a quanto avviene in natura. I commentatori sono d’accordo nel ritenere che la pianta rappresenti l’albero del bene e del male, presso cui avvenne la tentazione di Adamo ed Eva. Alcuni, tuttavia, vedono nella pianta la raffigurazione dell’Impero Romano.
Dal verso 37:
«Io senti’ mormorare a tutti ‘Adamo’;
poi cerchiaro una pianta dispogliata
di foglie e d’altra fronda in ciascun ramo.
La coma sua, che tanto si dilata
più quanto più è su, fora dall’Indi
nei boschi lor per altezza ammirata».
Dopo un susseguirsi di eventi allegorici la pianta dispogliata, come fanno quelle terrene, quando arriva la primavera, si rinnova, facendo sbocciare fiori d’un colore meno acceso delle rose e più intenso di quello delle viole:
«… si rinnovella
di suo color ciascuna, pria che ‘l sole
giunga li suoi corsi sotto altra stella;
men che di rose e più che di viole
colore aprendo, s’innovò la pianta…»
Poi in Purgatorio (XXXII,73 -75) adopera una similitudine con i fiori del melo (fioretti del melo) per piegare come gli angeli celesti siano desiderosi (ghiotti) di vedere Gesù:
«Quali a veder de’ fioretti del melo
Che del suo pome gli angeli fa ghiotti
E perpetua nozze fa nel cielo…».