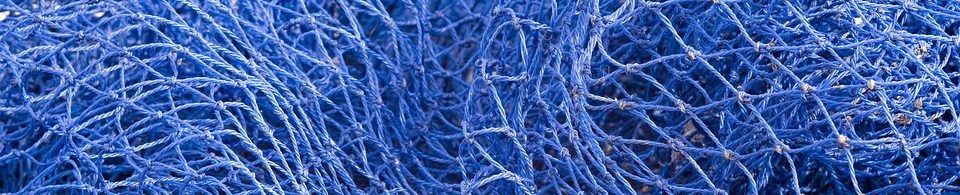DANTE SAPIENTE DI MEDICINA articolo di Letizia Gariglio
Quando percorriamo le pagine dantesche, in particolare dell’Inferno, ci accorgiamo che l’autore inserisce molte osservazioni di tipo medico, sia quando descrive le condizioni disgraziate e le pene dei dannati, sia quando introduce commenti su se stesso e illustra il proprio stato di paura. Osserveremo entrambe le condizioni: la descrizione di punizioni infernali per mezzo di malattie che nell’Inferno vengono somministrate come castighi per i peccatori, e le debolezze, potremmo dire le fragilità, di Dante viaggiatore dell’Oltretomba.
Dante era iscritto alla Corporazione dei Medici e degli Speziali, viene definito dagli studiosi come sapiens de medicina, vale a dire che conosceva teorie mediche medievali con riferimento in modo particolare a Ippocrate, Galeno e Avicenna, massimo esponente della medicina araba. Alla Galleria degli Uffizi è conservato un dipinto di Andrea del Castagno che raffigura Dante vestito con il lucco rosso, la veste dei medici. Nel Canto IV nomina i tre pilastri della medicina, che il viaggiatore dell’Oltretomba, Dante stesso, incontra nel Limbo, in mezzo a «gente di molto valore» e che pure non ha potuto assurgere ad altri luoghi beati perché privi del battesimo, nomina così Ippocrate, greco di Kos (460-377 a.C.), considerato padre della medicina occidentale, Galeno di Pergamo (129-201 d.C.), filosofo e medico, e il persiano Avicenna (980-1037 d.C.), medico, filosofo e matematico di cultura musulmana.
Nel canto XVII, veniamo a contatto con la quartana (malaria): Dante paragona se stesso, a causa della paura che prova, (e che rende coraggioso persino il servo di fronte di un valente signore) a chi sia ammalato di tale malattia, che rende febbricitanti e tremanti:
«Qual è colui che sì presso ha ‘l riprezzo
della quartana, c’ha già l’unghie smorte,
e trema tutto pur guardando il rezzo,
tal divenn’io alle parole porte;
ma vergogna mi fe’ le sue minacce,
che innanzi a buon segno fa servo forte».
Nel canto XX troviamo il termine parlasìa, vale a dire paralisi, termine dell’italiano antico che indica una malattia che deforma il corpo e rende sconclusionato il movimento: è la punizione infernale riservata agli indovini. Gli indovini, infatti, avanzano lentamente, piangendo, ed ecco che Dante si accorge che hanno il viso voltato al contrario, verso il dorso, costretti dalla legge di contrappasso a guardare indietro, per aver cercato di predire gli eventi del futuro.
Nel Canto XXIV facciamo conoscenza con l’oppilazion , cioè l’occlusione repentina dei canali anatomici, che causa l’epilessia: improvvisa incoscienza, convulsioni, smarrimento, amnesia. Siamo nella bolgia dei ladri, la settima, nella quale si muove una moltitudine di serpenti: i peccatori corrono nudi e spaventati con le mani serrate dietro la schiena. Una serpe si avventa su un dannato trafiggendolo al collo. E il peccatore arde incenerito. Il suo comportamento è analogo, dice Dante, a quello dell’epilettico che cade a terra, del tutto incosciente; al risveglio dalla crisi è tutto stordito. Simile a questo è il comportamento del peccatore:
«E qual è che cade, e non sa como,
per forza di demon ch’a terra il tira,
o d’altra oppilazion che lega l’uomo,
quando si leva, che ’n torno si mira
tutto smarrito della grande angoscia
ch’illi ha sofferta, e guardando sospira;
Tal era il peccator levato poscia».
Nel Canto XXIX , bolgia decima, siamo fra i seminatori di discordia : condannati a essere mutilati, sventrati, sviscerati… insomma letteralmente fatti a pezzi, parcellizzati.
«Tra le gambe perdevano le minugia
la corata pareva e ‘l tristo sacco
che merda fa di quel che si trangugia.
Mentre che tutto in lui vedere m’attacco,
Guardommi, e con le man riaperse il petto,
dicendo: “Or vedi com’io mi dilacco!»
I falsari di metalli vi sono condannati dalla legge di contrappasso a essere sfigurati dalla scabbia e dalla lebbra, così come in vita sfigurarono in vari modi la verità. Due dannati, seduti uno contro le spalle dell’altro, si graffiano furiosamente con le unghie, per liberarsi dal prurito, inutilmente.
«Io vidi due sedere a sé poggiati,
com’a scaldar si poggia tegghia a tegghia,
dal capo a piè di schianze macolati;
e non vidi già mai menare stregghia
a ragazzo aspettato dal segnorso,
né a colui che mal volentieri vegghia,
come ciascun menava spesso il morso
dell’unghie sopra a sé per la gran rabbia
del pizzico che non ha più soccorso…».
Sempre nel Canto XXIX menziona la peste, nello specifico la peste di Egina, quando dice:
«Non credo cha veder maggior tristizia
fosse in Egina il popol tutto infermo,
quando fu l’aere sì pieno di malizia,
che li animali, infine al piccolo vermo,
cascaron tutti…».
Si riferisce al momento in cui la dea Giunone scagliò la peste contro la ninfa Egina, amata da Giove.
Il Canto XXX è, per così dire, un concentrato di malattie. Siamo ancora nella bolgia decima, fra i falsari della persona, i falsari della moneta, i falsari della parola. Fra coloro che finsero di essere un’altra persona incontriamo i rabbiosi, condannati a correre, addentando gli altri dannati.
«Ma né di Tebe furie né troiane
si vider mai in alcun tanto crude,
non punger bestie, non che membra umane,
quant’io vidi due ombre smorte e nude,
che mordendo correva di quel modo
che ‘l porco quando del porcil si schiude».
I falsari di moneta sono affetti da idropisia, malattia causata da un accumulo di liquidi che fa gonfiare il corpo. Tocca a mastro Adamo che si lamenta della sete incessante che lo tormenta: l’idropisia gli deforma la pancia facendogliela gonfiare a dismisura.
«La grave idropesì, che si dispaia
le membra con l’amor che mal converte,
che ‘l viso non risponde alla vetraia,
faceva lui tener le labbra aperte
come l’etico fa, che per la sete
l’un verso il mento e l’altro in su rinverte».
I falsari della parola giacciono stretti uno all’altro, afflitti da un gran febbrone che procura loro il delirio: giusto contrappasso per chi ha falsificato con le parole, mescolando alle vere quelle false.
«E io a lui: “Chi son li due tapini
che fumman come man bagnate ‘l verno,
giacendo stretti a’tuoi destri confini?»
Poi si snoda un dialogo fra l’idropico, maestro Adamo e il falsario di parola Sinone, che turlupinò i Troiani con false spiegazioni sul cavallo.
.