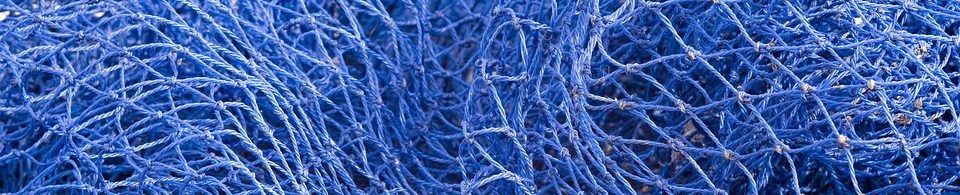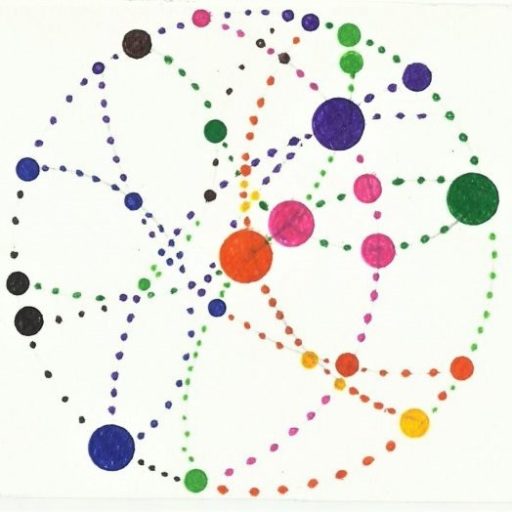IL RICORDO È POESIA di Pietro Paolo Capriolo
Traggo il titolo dalle parole del Pascoli in: Primi poemetti. Prefazione.
Soprattutto ad una certa età, la nostalgia di eventi trascorsi prende una vena poetica. La rimembranza, se non è legata a momenti traumatici vissuti in circostanze particolari quali campi di sterminio, violenze casalinghe, episodi di pedofilia… con il tempo, tende a sfumare i toni, a colorire gli episodi di nuovi significati, per lo più legati al rimpianto di una passata gioventù.
Ci sono fotografie in bianco e nero, sgualcite ed accarezzate più volte, che evocano emozioni lontane, ma ci sono anche fotogrammi mnemonici ed addirittura sequenze di immagini che emergono con innata vivacità e si traducono in parole che hanno la proprietà dinamica di rappresentare e comunicare eventi ed esperienze, quasi vivendoli nuovamente e farne partecipi gli uditori.
Anni fa, mi è capitato di ascoltare una vispa donna anziana, discendente di un piccolo imprenditore locale, rispondere alle domande che l’intervistatore le poneva sul passaggio dalla lavorazione dell’osso, mediante tornitura, alla produzione di cannule e cappucci in bachelite destinati alle penne stilografiche.
Esauriti gli aspetti cronologici e tecnici riguardanti l’azienda di famiglia, la signorina Amalia (per tutti: tota Amalia) cominciò a tratteggiare alcune dipendenti storiche, basandosi su propri ricordi e racconti del padre.
Principalmente, là si producevano bottoni in osso bovino/equino, ma non mancavano portatovaglioli (ne possiedo uno, ingiallito, del nonno e ancora mi illudo che sia d’avorio), interruttori elettrici a peretta, sonagli per bambini, agorai cilindrici, ecc. La polvere ed i residui di lavorazione, triturati, venivano venduti come fertilizzante ecologico molto apprezzato.
Rivedo la gestualità della narratrice nel rievocare quella volta che gli uomini della ditta andarono alla stazione a ritirare una partita di avorio grezzo per una ordinazione di particolare pregio. Tornarono sfilando con le zanne sulle spalle, una ciascuno, fra le meraviglie della gente del paese.
Anche mi risuonano ancora le parole dedicate ad una dipendente specializzata nel produrre i fori ai bottoni nella penultima fase della loro lavorazione, prima della lucidatura. L’addetta era Genia che aveva l’abitudine, ogni tanto, di corroborarsi con una sorsata di generoso barbera. Il suo lavoro era ripetitivo: i bottoni scendevano per gravità da una piccola tramoggia in una morsa di cuoio e feltro per trattenerli. L’operaia doveva avvicinare un attrezzo costituito da due (altre volte, quattro) punte di trapano che ruotavano simultaneamente. Una volta effettuati i fori, l’utensile doveva essere allontanato, nel tempo in cui il bottone cadeva di sotto in un serbatoio e se ne posizionava un altro, poi si ricominciava. Ora queste operazioni si possono fare in automatismo sincronizzato dal computer, ma allora era la vigilanza umana a garantire che tutto filasse liscio. Non era un lavoro faticoso, ma snervante e succedeva che i tempi non sempre coincidessero, che la gestualità fosse un po’ più energica ed allora il tondello d’osso si crepava o la spinta non abbastanza a fondo lasciando i fori appena accennati.
L’operaia che inscatolava il prodotto finito li scartava accumulandoli in un barattolo di latta chiamato scherzosamente “l’ossario” destinandoli alla macinazione per farne fertilizzante. Alla sera il papà di Amalia passava a controllare il danno, pesandoli sommariamente e poi faceva un burbero richiamo: «Genia, questi te li metto sul conto della settimana, così avrai meno soldi per il vino! O magari ti sostituisco con un’altra» ma poi non lo faceva mai veramente, rendendosi conto dello stress ripetitivo e della necessità di addestrare un’altra lavorante, con il rischio che la resa non corrispondesse poi alle sue aspettative.
Successivamente tota Amalia rievocò un episodio della sua vita infantile, dei tempi in cui la forza motrice per muovere i macchinari era ancora rappresentata dall’acqua della bealera (canale artificiale per irrigazione) a mezzo di una grande ruota metallica di mulino protetta da una baracca di legno al bordo di una stradina.
A confronto delle coetanee, poteva considerarsi una bambina fortunata per la condizione agiata di vita: possedeva perfino una bicicletta tutta sua, adatta alla statura.
Voglio evocare il suo racconto come farebbe ancora oggi chi osservasse la scena, cercando di non rovinare le sue emozioni infantili che mi sono piaciute.
֎ ֎ ֎
Siamo sul finire del primo decennio del secolo scorso.
Le prime foglie d’autunno galleggiano pigre, trattenute dai fili dell’erba che cresce lungo il fosso. Con movimento roteante si avviano verso il centro del rio, poi la corrente le trascina via, verso la saracinesca.
Proprio lì, le appassite barchette che sono il giocattolo della natura, dopo un attimo d’esitazione, infilano la liscia discesa che incanala una gran parte dell’acqua nell’apertura della baracca di protezione.
Ancora una volta Amalia resta incantata alla vista dell’acqua che luccica e gorgoglia.
La bambina, lasciando andare la bicicletta, fissa lo sguardo su quella bocca nera che inghiotte tutto quanto le arriva e, nel frattempo, emette un fracasso spaventoso, come se digrignasse i denti.
Lei sa che là dentro sta rinchiuso un mostro meccanico che si muove notte e giorno. Più di una volta, senza ubbidire al papà, sottobraccio alla sorella Evelina, ha socchiuso quella porta con il batticuore. Più che altro l’attira il fascino del proibito.
Tra scroscio e fracasso, la grande ruota con le pale le soffia addosso una nebbia fredda che ha l’odore della ruggine e, a paragone, mentre gira, pare un gigante.
La bambina si spaventa: chiude la porta e va a riprendere la bicicletta lasciata sul bordo della bealera che già rosseggia al tramonto.
L’acqua schiumosa, uscendo dalla baracca di legno, sotto i raggi del sole pare insanguinata: la ruota le ha spremuto la forza che mette in moto il lavoro della fabbrica di bottoni C. Pagliero, come un cuore che batte e pompa l’energia dal di fuori.