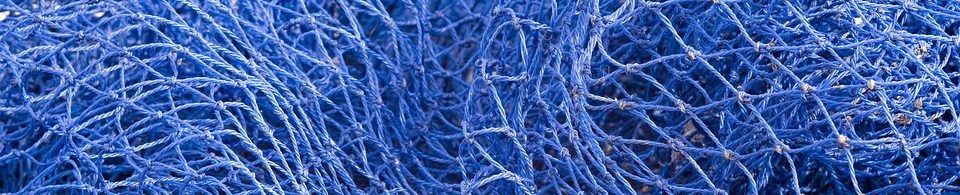ELOGIO DELL’INGENUITÀ INFANTILE di Pietro Paolo Capriolo (P. P. Roe)
Accingendomi a trattare dell’ingenua maniera di rapportarsi con la realtà ed il linguaggio degli adulti che spesso trasuda dalle parole dei bambini, la storia ancora non era così gravemente precipitata in tragedia nel cuore dell’Europa. Sento ora però di dover dedicarvi almeno una pagina, sforzandomi di mantenere i bambini comunque al centro della trattazione. Non oso però esprimermi sulle modalità della loro elaborazione dell’evento, perché questa è materia da psicoanalisi.
Le recenti scene di esodo che popolano i nostri schermi televisivi ogni qual volta i notiziari affrontano il dramma ucraino ci fanno stringere il cuore alla vista dei bimbi al seguito di donne che, pur dignitosamente trattenendole, vanno benedicendo di lacrime la terra patria che stanno lasciando. Forse perché biondi, questi visini pallidi sembrano muoverci maggiormente all’empatia che non tanti loro coetanei che, da altri scenari della Terra, decenni di reportage ci hanno mostrato. Un po’ com’è successo con il virus: quando lo abbiamo visto mietere centinaia di vittime a Bergamo e dintorni lo abbiamo preso più sul serio. L’emergenza umanitaria ora è qui, vicino a noi, ma ogni bambina/o cui la guerra, la miseria, l’ignoranza o la tracotanza talebana hanno portato via il sorriso ci interpella con un innocente ed impressionante perché senza risposta.
Insieme, ed oltre, alle dimostrazioni di generosa accoglienza, solidarietà e compartecipe aiuto che nel mio piccolo posso mettere in atto, anche la mente si va mobilitando e mi torna alla memoria una massima appresa a scuola e soprattutto a scuola (luogo di quarantennale mestiere) ho praticato: Maxima debetur puero reverentia, ossia che ai fanciulli si deve incondizionato rispetto. Questo è quanto di solito si ricorda ed in effetti è il messaggio essenziale, ma nell’andare scartabellando (si fa per dire, perché il motore di ricerca in Internet ti trova anche il contesto), che cosa intendesse dire davvero Giovenale nella sua XIV satira, ho trovato l’annesso siquid turpe paras, se cioè si sta preparando qualcosa di nefando.
Cosa di più turpe della guerra in cui sono coinvolti gli inermi civili? Gli strateghi non hanno la disposizione né la sensibilità di calcolare di fare a meno di coinvolgerli, anzi pare che sugli scacchieri di tutto il mondo ormai questa sia un’opzione in più, un’efficace arma di deterrenza con il solo marchio della gratuita criminalità. Il poeta del secondo secolo d.C. poneva almeno un limite di riguardo verso l’infanzia, anche nell’iniqua predisposizione della violenza.
Ma veniamo all’intento iniziale. Ogni genitore, magari proprio con i figli già da parecchio adulti, ricorda volentieri i loro primi approcci verbali con la realtà e va nostalgicamente snocciolando a distanza di decenni errori fonetici, morfologici e sintattici quali: la ampandina, l’abulanza, sì vieno (in risposta al richiamo: vieni?), semafero, Mochina al posto di Monica, pompette per polpette, ecc…
Qualche volta l’improprietà semantica tradisce una confusione di valori di giustizia e di potere sanzionatorio: «lo dico alla tua mamma, così poi ti bisticcia!». Qui il rimprovero è ancora confusamente legato alla conflittualità inter pares. Altre volte il piccolo ha bisogno di una conferma collegata alla sua esperienza quotidiana, soprattutto se riferita a concetti piuttosto astratti, quali la percezione del tempo. Ad es. a me è successo che, avendole procrastinato l’esaudimento di una richiesta al giorno successivo, la piccola Elisa mi abbia domandato: «Ma domani è dopo dormito?»
Anche nel gioco di immaginazione del medico e del paziente emergono particolari tratti dal mondo esperienziale infantile, tipo la frase captata dal dialogo fra alcune bambine: «…poi il termometro si mette in moto». Lo strumento probante lo stato di benessere o di affezione febbrile è quello sperimentato sulla propria pelle. Prima dell’evento dei marchingegni elettronici, era lo spostamento sull’astina capillare del liquido argenteo o rosso a decretare il discrimine fra lo stato di malattia e quello di salute e dunque la metafora di messa in moto tratta dalla cinetica veicolare per loro era opportunamente rievocativa, anche se risulta parecchio strana all’adulto.
Ho sorriso bonariamente all’obiezione di Francesca preoccupata che le vestali romane avessero l’incarico di tenere sempre acceso il fuoco sacro: «Ma non si fanno male?». Solo la metafora gestuale poteva spiegare il suo stupore. Infatti, mentre formulava la domanda, porgeva accostate le mani come a trattenere carboni ardenti. Bastò per la spiegazione sostituire l’infinito presente tenere con mantenere, impedire che si spegnesse, provvedere sempre una scorta di olio combustibile per la lampada… Di seguito a ciò, prestai più attenzione a quel verbo, anche in modo ossessivo. Ricordo che quell’anno fui scortese con una collega che si lasciava andare a meridionalismi verbali: nel preambolo della sua relazione quadrimestrale le scappò: «Tengo una classe di alunni indisciplinati», al che io sbottai: «E dove la tieni, in gabbia?», spiazzandola sull’uso generico del verbo avere, per non dire dell’affidamento della sezione che è prerogativa esclusiva del capo d’Istituto.
A Marco, ormai deceduto tragicamente, rivolgo questi ultimi due ricordi. La scuola non era ancora iniziata, ma quel pomeriggio era lì comunque, perché la mamma era operatrice scolastica e forse non aveva modo di collocarlo altrove. Avevo da trasportare del materiale dall’auto in cortile al laboratorio di scienze e, vedendolo annoiato, gli proposi di aiutarmi ed egli lo fece volentieri. Dopo un’oretta che se ne era già andato, ritornò dicendomi: «Non ho più voglia». Alla domanda di che cosa non avesse più voglia, rispose: «Di aiutarti». Solo allora ricordai di aver formulato la domanda di collaborazione facchinesca così: «Hai voglia di aiutarmi?». Avendo visto arrivare la figlia di una maestra, anche lei parcheggiata a scuola, voleva andare a giocarci insieme, ma prima sentì l’esigenza di sciogliersi dal suo impegno!
Sono legato al ricordo di questo bambino, particolarmente per una costatazione che ebbi modo di trascrivere nell’immediata freschezza di relazione dopo un’attività nel laboratorio sperimentale. Gli alunni di sei anni avevano immerso in vaschette contenenti acqua identici barattolini zavorrati con biglie di vetro e stavano descrivendo il comportamento di questi strani natanti: «Va un po’ giù; pende di qua; no un po’ di qua e un po’ di là, il mio è andato sotto» e via di questa maniera. Quando toccò a Marco, egli stupì tutti con: «Sta… come si siedono i cani». Risate dei compagni; sguardo perplesso e quasi di rimprovero della sua maestra; qualcuno si aspettava almeno un richiamo a non dire sciocchezze. Invece, un po’ per estemporaneo momento fortunato ed un po’ per l’abitudine ad ascoltare il linguaggio infantile, ebbi l’intuizione di elogiarlo addirittura, rassicurandolo di aver capito cosa intendesse dire e spiegandolo all’assemblea. Non conoscendo la parola inclinato egli rappresentò la situazione con l’immagine familiare del cane che in quella posizione può rendere l’idea della diagonale di una porzione di spazio preso in considerazione. Questa esperienza l’ho poi inserita in un articolo riguardante i modi infantili di approssimazione scientifica alla realtà e mi valse una citazione al convegno Rhetoric and Argumentation sulle metafore linguistiche tenutosi nel 1997 a Lugano.
A volte anche l’ipercorrezione verbale (nel senso di troppa insistenza) o la fretta di “adultizzare” i bambini sono sintomi di subdola violenza. Lasciamoli almeno inizialmente esprimersi come sanno e poi, a distanza di anni la stessa parola ampandina, di cui sopra, ci farà ancora sorridere teneramente.
Come s’usa dire, i nomi dei personaggi sono di fantasia, meno quello della nipotina Elisa che allora non aveva ancora tre anni.