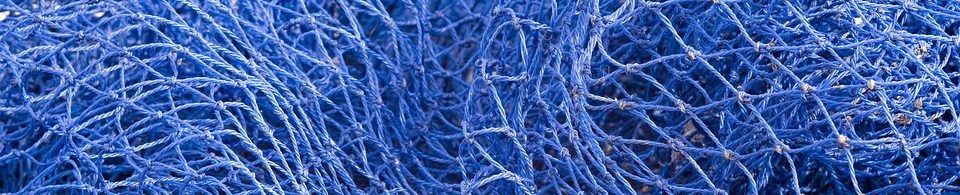GLUB GLUB. EMERSIONE DI RICORDI di Pietro Paolo Capriolo
Per un precedente scritto (Fare faville, n.38/agosto 2021) avevo preso lo spunto dal regalo d’un giocattolino da quattro soldi basato sull’utilizzo di pietre focaie per accendini. Anche questa volta mi rifaccio ad una situazione simile. All’uscita dello stabilimento, mio papà aveva assistito alla dimostrazione di funzionamento d’un giocattolo di poco valore, ma in grado di destare la curiosità di grandi e piccoli e si lasciò convincere all’acquisto.
Alla sera, davanti ai miei occhi sgranati, svolse l’involucro di semplice carta di giornale e ne estrasse un “coso” di color verde, costituito essenzialmente da un tubetto di bachelite (la plastica di allora) che doveva vagamente rassomigliare ad un palombaro. Le dimensioni erano su per giù quelle di un cappuccio per penne stilografiche e, come quello, filettato di sotto per reggere un coperchietto rimovibile con tanto di forellino centrale dal diametro di un millimetro o poco più. Due dita di cavo elettrico simulavano per flessibilità e colorazione nera il tubo di gomma che collegava la bombola sulla schiena alla sferetta che rappresentava la testa rinchiusa nell’estremità dello scafandro. Rudimentali braccia erano incollate ai lati del corpo.
Tutto qui: ci voleva fantasia per immaginarselo come un giocattolo. Ma poi papà svitò il fondello forato e versò nella pancia del palombaro un cucchiaino circa di una miscela di polvere che ben conoscevo.
Ancora la si può reperire sugli scaffali dei supermercati accanto alle acque minerali; credo che ora ne siano superstiti poche marche, ma a quei tempi le polveri per rendere frizzante la comune acqua di rubinetto erano diverse.
C’erano quelle da utilizzare in due tempi, con le bustine colorate differentemente e ben divise nella scatoletta. Si cominciava col versare nella bottiglia munita di macchinetta e tappo di ceramica con guarnizione di gomma la prima polvere, vale a dire comunissimo bicarbonato di sodio. Poi, con perizia, l’altra, affrettandosi a tappare subito la bottiglia per poi capovolgerla più volte. Lì dentro avveniva la reazione e si sviluppava anidride carbonica solubile, la famigerata CO2 che contribuisce ad innalzare la temperatura del pianeta, ma altresì buonissima da trangugiare come componente tipica dello spumante e delle bevande gassate analcoliche. L’ingrediente della seconda bustina era quasi sempre acido malico (derivato, come dice il nome, dalle mele) tagliato con acido citrico (preso dagli agrumi) e/o tartarico (ricavato dall’uva), sostanze tutte che si impiegano in pasticceria, confetteria ed industrie conserviere. Le varianti erano per personalizzare la ricetta e andare incontro ai gusti dei consumatori.
Le bustine con i reagenti separati erano le più adatte per affidare ai bambini l’incarico di preparare l’acqua frizzante prima di mettersi a tavola e in famiglia quest’incombenza ci tenevo ad assolverla io.
Le marche con la miscela già pronta in busta unica richiedevano maggiore destrezza, come quelle d’oggigiorno, ma gli odierni appassionati di questa specialità hanno col tempo acquisito sufficiente esperienza.
Papà aveva quella volta mescolato le due polverine su un foglio bianco di quaderno, prelevandone la quantità occorrente da introdurre nel cilindretto e poi riposto il rimanente in una busta arancione recuperata dalla posta, regalandomela come scorta per successive “immersioni”.
Si andò alla ricerca di un recipiente di vetro. Il contenitore (detto arbarella) per conservare i peperoni crudi sotto vinacce risultò il più indicato, perché consentiva di farvi passare l’intera mano e, a differenza di bottiglioni con collo largo, non era di colore scuro.
Costituito il piccolo mare, cioè dopo averci messo dentro l’acqua, toccò al palombaro effettuare la sua prima missione: scese a perpendicolo fino in fondo e ci stette immobile quel tanto da indurre delusione al non veder succedere niente. Non per molto però, perché parve prendere vita ondeggiando un po’ e poi cominciò a sollevarsi svelando di sotto una bollicina d’aria che, ingrandendosi, aumentava la spinta ascensionale. Quando la testolina dello scafandro emerse, la bolla scoppiò, causandone la discesa. Quasi subito una seconda bolla si formò sull’orifizio del forellino nel fondello filettato e s’innescò un altro processo di risalita. Andò su e giù parecchie volte finché la miscela non fu tutta bagnata e non lo recuperai con il braccio immerso fino al gomito nell’acqua che, naturalmente, strabordò dal contenitore. La mamma fu indulgente e consigliò per la volta successiva di sistemare il vaso all’interno di una bacinella.
Imparai anche a fare “le pause di decompressione”: nel caso specifico non si trattava di compensare la pressione polmonare, ma di asciugare bene l’interno del cilindretto ed asportare depositi di bicarbonato intorno al forellino. L’asciugatura era indispensabile per non far iniziare la reazione fuori dall’acqua in fase di caricamento.
Venne la volta che volli sperimentare l’immersione in ambiente diverso, non così deserto come nel mio barattolone. La boccia con il pesce rosso della cugina andava proprio bene e però non fu semplicissimo convincerla. Dovetti assumermi la responsabilità dell’eventuale avvelenamento dell’animaletto e nel caso dell’infausto evento procurargliene un altro, compiere l’esperimento lontano dagli occhi delle zie ed infine ripeterle più volte il ragionamento: «Se l’acqua frizzante noi la beviamo, perché dovrebbe far morire il pesciolino?» Di fatto non morì, ma tolta la prima volta non mi fu più consentito ripetere l’immersione in ambiente biologico. Mi rivolsi agli amici allora, millantando di possedere una polvere magica.
La provvista regalatami dal papà era finita, ma avevo imparato a farmi la miscela da solo, migliorandone anche la composizione, cioè riducendo un po’ la quantità della prima polvere che tendeva ad intasare il forellino, specialmente a fine missione del palombaro. Veniali furtarelli di polvere effervescente non furono notati o comunque ben tollerati.
Estesi dunque il mio raggio di azione fra gli amici di gioco ed i chierichetti, recandomi da loro dopo la raccomandazione di procurarsi il contenitore di vetro. Quando però mi rivolsi all’istituzione scolastica, non ottenni la medesima attenzione. L’amico e compagno Sandro ne attestò il funzionamento, ma la sua testimonianza non valse a convincere la maestra che mi fece subito esporre il segreto per far emergere il palombaro, bloccando così la curiosità dei coetanei. Addusse poi la scusa di non avere sottomano (ma neanche nei giorni a venire?) un vaso adatto e che per giocare a scuola non c’era tempo.
Peccato! In primo luogo, per la mia gratifica pubblica, ma -ripensandoci ora- per l’occasione didattica persa da parte della docente di affrontare l’affascinate tematica del galleggiamento. Indipendentemente dalla recriminazione indotta da questo ricordo, da insegnante distaccato su laboratorio di scienze ed aggiornatore di colleghi, ho fatto numerose ed affascianti serie di esperimenti basati sulla spinta di Archimede con materiale di recupero, plastilina variamente modellata, diavoletti di Cartesio realizzati in economico bricolage, danzanti palline di naftalina e perfino con soldatini di piombo (metallo pesante per antonomasia), appesi al braccio di una bilancia in bilico sull’asta, cioè come il simbolo della giustizia, e poi immersi in acqua.
Quando giocavo con il palombaro, né io né i coetanei conoscevamo il principio di Archimede. Il modello prototipico a cui ispirarsi per darci una spiegazione plausibile era quello costituito dalle bollicine che si sollevavano dal fondo di bottiglia e bicchieri per raggiungere la superficie, esplodere e disperdere il loro gas nell’aria.
La bolla sviluppatasi sotto il cilindretto era abbastanza grande e poteva dunque spingere su anche il giocattolino: dell’aumento di volume dovuto alla bolla che gli stava attaccata, ma non ne aumentava il peso/massa non potevamo tenere conto, perché nessuno ci aveva resi edotti del particolare. Eravamo in veniale infantile errore, concependo la bolla un po’ alla maniera di Super Man (il Nembo Kid dei nostri felici anni) che, dotato di forza extraterrestre, sostiene e riporta sul ponte un’automobile che sta precipitando di sotto. Bolla e palombaro invece diventavano un corpo solo ma di maggiore volume nell’acqua e per questo venivano su, finché durava il loro abbraccio. Pur gravati da questa ignoranza, vivevamo spensierati la nostra vita come l’umanità tutta, prima che il geniale siracusano Archimede prendesse quel suo illuminante bagno.
Che una piroga di legno galleggi è risaputo da tutti, data l’evidenza e senza conoscere il principio scientifico su cui si basa il fenomeno. Che però lo possa fare anche una pentola d’acciaio inox nel lavello è meno intuibile, per non dire addirittura che possa sostenersi nell’aria un aereo di metallo carico di merci e passeggeri. Ma questo potrebbe essere oggetto di un’altra mia voglia di scrivere a proposito dei fratelli Montgolfier e dei Wrigt, altrettanto fratelli anche questi.
Per ora mi limito a confidarvi che nella mia carriera di docente quando volevo introdurre l’argomento, prima lo facevo precedere da una breve inchiesta sul significato di spinta.
Questo termine evoca sentimenti negativi ed è legato al concetto di malvagità, di dispetto, di prepotenza, d’illecito o, per lo meno, di scorrettezza sportiva. Quanto alla spazialità, la sua pertinenza nel linguaggio per lo più riguarda l’orizzontalità (spingere fuori dalla porta o dal bordo della panchina, spingere un’auto in panne sulla strada). Quanto al moto, esso è rivolto quasi sempre dall’alto verso il basso (giù dalle scale).
Un ragazzino mi fece osservare che per il movimento verticale al contrario si dice tirare su, come per un sasso scagliato in alto, come lavora la gru nel cantiere con i pesi, come fa la mamma tendendo il braccio al piccolino sul pavimento per aiutarlo a sollevarsi… Suscitando poi l’ilarità dei compagni, ammise che si può usare il termine spingere: «Sì anche in su, come quella volta che in palestra un amico mi ha aiutato a salire sulla pertica, spingendomi sul sedere».
Archimede, più che il prototipo del pestifero compagno che vuole farti precipitare giù dalle scale, con la sua spinta rappresenta invece proprio lo stereotipo dell’amico dallo spontaneo e sicuramente casto gesto sulle natiche altrui!