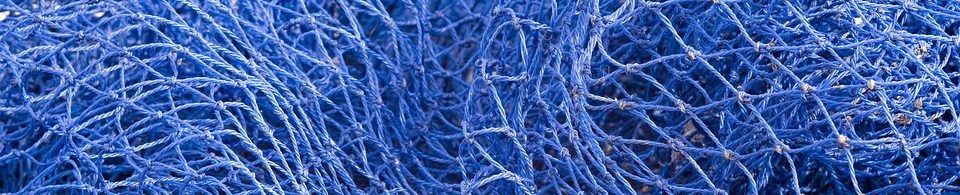ANCORA VIVO E GIÀ ALL’INFERNO. BONIFACIO VIII di Letizia Gariglio
«Nel mezzo del cammin di nostra vita / mi ritrovai per una selva oscura/ …»: mi sono già lungamente soffermata sul fatto che Dante considerava il momento di inizio del suo viaggio come protagonista della Commedia il punto mediano della sua vita personale: nato il 2 giugno 1265, all’età di trentacinque anni riteneva di poter vivere fino a settant’anni. Non fu così, perché. Dante morì nel 1321, vent’anni dopo. Nell’articolo Quattro pianeti per un viaggiatore, pubblicato su Parole in rete nel maggio 2021, ho spiegato come quello dell’inizio del viaggio fosse per Firenze l’anno 1300 ab Incarnatione, tuttavia per noi e i nostri parametri temporali attuali quell’anno è chiamato 1301. 1300 rappresenta un decimo di un semiciclo della Precessione degli Equinozi, della durata, secondo Dante, di 13000 anni. La durata completa del ciclo, di 26000 anni, definita dagli antichi Anno Platonico o Grande Anno si discosta di soli 40 anni dai calcoli degli astronomi odierni. Il semiciclo, o periodo di 13000 anni, era considerato importantissimo dai popoli antichi (che conoscevano benissimo il fenomeno della precessione) perché segnava con la sua cadenza un punto di volta, il punto mediano nel raggiungimento, negli eventi universali, di un ciclo del mondo. Il punto mediano era considerato una sorta di centro dei tempi, un punto di equilibrio, nel quale si possono conciliare contrasti e opposizioni. Le porzioni decimali erano oggetto di particolare attenzione.
Ma vi è un ulteriore significato nell’anno 1300, avente valenza nettamente polemica con il Papa del tempo di Dante, Bonifacio VIII. Il Papa aveva decretato l’anno 1300 come anno del Giubileo, ed esso si chiudeva il 31 dicembre 1300. Roma e il Papato non solo differivano da Firenze nella conta degli anni, ma differivano anche per il fatto che il Papato contava dalla nascita di Gesù, a Nativitate (25 dicembre) , e Firenze contava ab Incarnatione (25 marzo). Ciò significa che tra la chiusura del Giubileo dell’anno 1300 e l’inizio dell’anno fiorentino 1300 trascorrevano tre mesi: diveniva impossibile per i fiorentini avere una porzione del proprio anno 1300 all’interno dell’anno romano del Giubileo.
Dante riteneva Bonifacio VIII degno di essere condannato all’Inferno fra i simoniaci: concordava con tutte le accuse rivolte dai Colonna a quel Papa, con quelle dei francescani spirituali, quelle del re di Francia, vale a dire che la sua elezione al soglio papale fosse stata del tutto illegittima e fosse a monte basata sulla fraudolenza esercitata dal Caetani nei confronti di Celestino V, spinto da lui ad abdicare e subito dopo tradito con la cattura e la prigionia. Quando Bonifacio diede disposizione di rinchiudere Celestino, si narra che questi disse al nuovo Papa: «Otterrai il Papato come una volpe, regnerai come un leone, morirai come un cane».
L’odio di Dante verso Bonifacio VIII nacque fin dalla elezione, poiché il Papa, secondo le aspettative, avrebbe dovuto mettere pace fra guelfi Neri e Bianchi in Firenze, invece da subito si dichiarò favorevole ai Neri: Dante lo riteneva responsabile della rovina di Firenze e della propria condanna a vivere in esilio. Riuscì a sbatterlo all’Inferno prima che morisse. Usò uno stratagemma letterario, fingendo che il Papa Nicolò III, conficcato a testa in giù nella bolgia dei simoniaci, immaginasse che stesse giungendo Bonifacio che avrebbe preso il suo posto, mentre egli sarebbe precipitato più giù in fondo al pozzo con altri papi già caduti in quel luogo. «Se’ tu già così ritto, / se’ tu già così ritto, Bonifacio?», domanda Nicolò e aggiunge: «…non temesti tòrre a ‘nganno / la bella donna,e poi di farne strazio?», e la bella donna è la Chiesa. Poi Virgilio suggerisce a Dante di dire: «son son colui che credi».
Sistemato Bonifacio all’Inferno con l’inganno letterario, Dante torna a lui nel canto XXVII, dove il Poeta fa pronunciare a Guido da Montefeltro, duca di Urbino, la definizione riguardante Bonifacio: «lo principe de’ novi Farisei».
Ma se qualcuno vuole apprezzare la grottesca teatralità del personaggio è a Dario Fo che si deve rivolgere.
Chi di noi rammenta il capolavoro Mistero Buffo del nostro Nobel per la Letteratura, Dario Fo? La mia generazione ha avuto la fortuna di assistere alle rappresentazioni di Mistero Buffo più volte e in circostanze diverse: Fo lo recitava in teatro, nelle sale e nei cortili delle scuole, delle Università e dei Politecnici, sulle piazze e all’interno delle fabbriche. Aveva cominciato a strutturare quello spettacolo dal 1963, e nel ’69 andò in scena a Milano, sulla base di un canovaccio attorno al quale molto improvvisava, tenendo inchiodati gli spettatori. Una volta iniziò la rappresentazione alle 21,30 e ale 2, 30 stava ancora in scena: fu la Rame a chiedere personalmente al pubblico di essere gentile e andare via – aveva paura, disse, «che gli venisse un coccolone». Il grande guitto aveva reinventato la giullarata, forma di teatro popolare raccontata da un solo attore. Il titolo, Mistero Buffo, rimanda al titolo di una commedia del 1917 di Vladimir Majakovskij, in cui le vicende della rivoluzione sono trasposte su un piano biblico: anche nel Mistero Buffo di Fo i monologhi orbitano su episodi di argomento biblico, reinterpretato nella chiave dell’Autore. Ricevette il Nobel nel 1977 e motivava l’Accademia di Svezia: «…se qualcuno merita l’epiteto di giullare, nel vero senso della parola, questo è lui. Il misto di risa e serietà è il suo strumento per risvegliare le coscienze sugli abusi e le ingiustizie della vita sociale».
Tra i misteri uno dei più esilaranti è quello riguardante Bonifacio VIII: è ancora possibile trovare alcune registrazioni in Rete. Ricordo che la scena iniziava con una piccola prefazione, dove Fo mimava la sottrazione del soglio pontifico da parte di Bonifacio a Celestino V, sotto forma di un gioco di bambini, poi Bonifacio prendeva la scena, cantava un canto paraliturgico di tradizione catalana, mentre si preparava con tutti i paramenti sacri per una processione; Fo mimava le azioni del Papa vanesio, ma contemporaneamente da solo rappresentava il primo, il secondo, il terzo corista (con le diverse partiture vocali), quando interveniva il quarto corista, stonato, il pubblico già non si tratteneva più; poi Bonifacio lo rimbrottava, e contemporaneamente mimava gli oggetti, il pesantissimo mantelon pieno di pietre preziose, ma anche la mitria, i guanti, in un crescendo di effetti mimici (sempre cantando tutte le parti del coro). Memorabile pezzo di teatro!
In quel periodo ricco di fermenti teatrali e di esperienze indimenticabili un giorno con amici teatranti, con cui condividevo appassionanti ricerche e sperimentazioni, andammo a trovare Fo a Milano, nel suo teatro-capannone. Ci introducemmo silenziosi, per non disturbare le prove in corso. Ma Dario Fo interruppe le prove per accoglierci con una festosa e calorosa accoglienza: il Gigante ci fece sentire meritevoli della sua attenzione, quasi noi fossimo degni colleghi.
Non ricordo che cosa stesse provando, ma mi piace tanto immaginare che fosse il mistero di Bonifacio VIII.