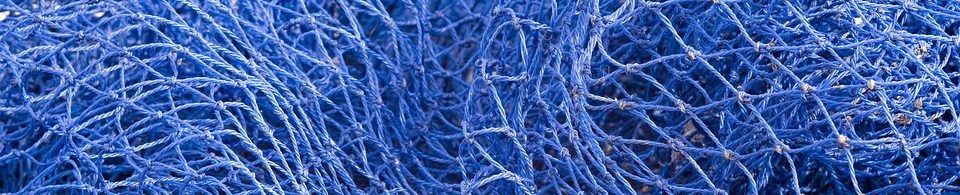FARE FAVILLE. PERSONALE STORIA DI IMPRINTING LUMINOSO di P.P.Roe (Pietro Paolo Capriolo)
All’uscita dello stabilimento, mio papà incontrava venditori occasionali di oggettistica da quattro soldi e di giocattolini e qualche volta si lasciò convincere all’acquisto. Mi portò una sera una piccola motocicletta di latta di cui solo la ruota anteriore girava, mentre dalla posteriore, di sola figura, spuntavano ai lati due rotelline che stabilizzavano il tutto come un triciclo.
La lamiera era riciclata da lattine su cui si intravvedevano dal lato interno ideogrammi orientali. Il movimento era assicurato da una molla a rilascio con carica a chiavetta, come una sveglia. Un ingranaggio era collegato alla ruota anteriore ed un altro ad una rotellina zigrinata che spuntava proprio in mezzo al grosso fanale della motocicletta. Un lamierino gli sobbalzava sopra trattenendo una pietrina da accendisigari. L’effetto sonoro richiamava quello di un motorino e le scintille prodotte ne facevano un passatempo per la sera, senza impiego di pile e lampadine. Lo zio Giuvanìn, fumatore, mi garantiva una certa riserva di pietrine, ma non ne servirono molte, perché la molla si spezzò presto.
Da ragazzini ci procuravamo pietre focaie direttamente dai cumuli di ghiaia dei cantieri stradali o visitando il greto del fiume Po. Le riconoscevamo facilmente per il colore giallino del quarzo e per l’inconfondibile odore luciferino allo sfregamento su altri sassi dovuto al disolfuro di ferro contenuto; questo noi ancora non lo sapevamo, ma ci serviva da sicuro indizio. Non ricordo che, al di fuori dell’effetto pirotecnico della produzione di lunghe scie luminose strofinandole sui ruvidi gradini di pietra delle scale, qualche coetaneo fosse riuscito ad accendere con esse un fuoco: non ne avevamo bisogno, data la grande disponibilità di fiammiferi; già, i fiammiferi, cose che i bambini di oggi stentano perfino a conoscere.
Nel contesto di lezioni di storia sugli uomini primitivi, di queste pietre ne ho spesso portati dei campioni a scuola, ingenerando curiosità negli alunni e facendo fare loro esperienze che un lontanissimo tempo fa erano comuni ai bambini dell’età della pietra i quali, negli antri delle caverne, disponevano di soli sassi per giocare e prima o poi tutti ne scoprivano la meravigliosa proprietà.
Ora è meno facile in città per i bambini “da appartamento” (come li commisero a volte) procurarsi le pietre in questione. Io consiglio di fare attenzione ai sassi calpestati durante la visita alle tombe nei cimiteri, fra i vialetti cosparsi di ghiaia di fiume, con l’avvertenza di non caricarsi di inutile zavorra, ma di sceglierne due o tre, dopo l’immancabile prova olfattiva dello strofinamento che sempre funziona anche in piena luce.
L’accensione del fuoco con le pietre focaie è stata per millenni una valida alternativa a quella per attrito di legnetti resinosi. Ho prima accennato ad esperienze di scuola e ne voglio citare un’altra con componenti di sfida e di inganno insieme. Abbiamo mandato ad altre sezioni (anche di scuole diverse) una stecca di abete con numerosi piccoli crateri anneriti da incipiente combustione insieme a bastoncini cilindrici lunghi una spanna con le estremità arrotondate e carbonizzate, facendo intendere di essere riusciti ad accendere così il fuoco, come si vede fare dai pellerossa nei film. Immancabilmente scattava il desiderio di emulazione, ma altresì la delusione per l’insuccesso accompagnata da fastidiosi arrossamenti alle mani: «Come ci siete riusciti?» Alla scontata domanda, una risposta sconcertante ed anacronistica: «Con il trapano elettrico!». Facevamo ruotare lungamente a media velocità il bastoncino sulla base, producendo tanto fumo azzurrognolo e particelle incandescenti che però volavano via. Volendo perfezionare il dispositivo, si scava il buco profondo almeno due centimetri con un diametro maggiore di quello della punta di legno rotante, così da trattenere dentro la primitiva camera di combustione qualche briciola arroventata. Nell’espediente c’è anacronismo sì, ma solo per il mezzo impiegato, non per il metodo su cui si basa anche l’antico trapano a mano in uso ad esempio presso gli Egizi. La punta è azionata dal movimento avanti e indietro di un arco a corda lenta attorcigliata all’asta e tenuta pressata al pezzo da forare con l’incavo di una mano che stringe una conchiglia dalla liscia madreperla interna.
L’uso delle pietre focaie semplifica il procedimento, eliminando il lungo e un po’ doloroso processo di attrito, producendo all’istante una particella ad alta temperatura: la scintilla. L’abilità acquisita con l’esperienza indirizzava le scintille su materiale facilmente infiammabile, ad esempio su filamenti di stoppa intrisi di salnitro o su frammenti di particolari funghi non commestibili, come si usò fare fino alla diffusione di fiammiferi di sicurezza in tutte le case. Nel suo corredo, la mummia riemersa dai ghiacci del Similaun, Ötzi, aveva alcune pietre focaie e un’esca costituita da un fungo spugnoso essiccato.
Con la pandemia, è ritornato l’uso della parola coprifuoco, che dai tempi dell’ultima guerra non s’usava più, per indicare la proibizione ad uscire alla sera di casa, ma nel Medioevo, addirittura ad uno speciale rintocco di campane, s’imponeva di coprire con le ceneri le braci del focolare per evitare incendi notturni (questa è l’origine del nome). Molto più improbabile che si riprenda a dire “battifuoco” per significare uno strumento un tempo diffusissimo e più noto come acciarino. Hans Christian Andersen scrisse una fiaba intitolata L’acciarino magico, poco conosciuta e di difficile riproposta oggi, anche perché vi è implicata una principessa che nel sonno, non consenziente, viene baciata da un soldato semplice che con la magia se la fa condurre alla sua locanda (Cfr. la recente polemica con la Walt Disney per la rottura dell’incantesimo di Biancaneve con il bacio del Principe Azzurro!).
Equiparare l’acciarino al moderno accendino non è corretto, anche se lo scopo è sostanzialmente il medesimo, e non spiegherebbe perché avesse anche una forte valenza affettiva di appartenenza familiare, nonché comparisse perfino negli stemmi araldici. Senza meccanismi, consisteva in una barra piegata a D – B per favorirne l’impugnatura, di acciaio temprato, riutilizzando anche lime ormai sdentate. Con esso di strofinava, più spesso si batteva, sul filo di una pietra focaia scheggiata, facendo sprigionare scintille.
Dante col dire «onde la rena s’accende, com’esca sotto focile» (Inf. XIV, 37-38) intende semplicemente l’acciarino; successivamente con l’uso delle armi da fuoco, un focile meccanizzato cominciò ad essere montato alla base di canne metalliche che contenevano la polvere da sparo ed il proiettile. Le preziose faville dovevano cadere con precisione in una fossetta con la polvere d’innesco e si scelse allora di immobilizzare l’attrezzo d’acciaio inclinandolo con cura matematica e di farlo percuotere dalla pietra focaia tenuta da un morsetto a vite con due ganasce che ricordavano un po’ le fauci di un cane (Ancora si dice alzare/abbassare il cane di pistole e fucili). Fucile per antonomasia divenne il nome delle più diffuse armi, dopo l’archibugio ed il moschetto. A proposito di quest’ultimo, chissà perché il più famoso dei moschettieri, D’Artagnan, non ne fa mai uso?
La pietra focaia è essenzialmente una selce e l’uomo dalla preistoria familiarizzò con essa scheggiandola in vari modi per ricavarne utensili. Colpendola, si spezza perché è fragile (da frangere = spezzare), ma molto dura. Anche il durissimo diamante, più che tagliato, viene sapientemente colpito e spezzato. Dopo una trentina di spari, la pietra da fucile doveva essere sostituita e pazientemente martellinata perché (e qui è interessante rivelazione) era la pietra a staccare minute particelle arroventate dall’acciaio. La durezza della selce si aggira infatti sui 6 – 7 gradi della scala di Mohs, mentre l’acciaio dell’era preindustriale raggiunge appena i 4 – 5.
Si deve al conte Auer von Melbach una rivoluzione nell’uso della pietra focaia che continua ad essere chiamata così, ma è un prodotto artificiale grigio. Per fusione si ottengono cilindretti tutti uguali, di lunghezza e di diametro voluti, che soprattutto si consumano con regolare continuità. Ora è una rotellina zigrinata d’acciaio a rasparne la superficie, come nel mio giocattolino, ed a strapparne via materiale incandescente che può incontrare uno stoppino imbevuto di benzina o un beccuccio distributore di gas propano liquefatto.
Raccomando di leggere da Il sistema periodico di Primo Levi il capitolo dedicato al CERIO dove racconta come sottrasse ai nazisti una quarantina di cilindretti di lega ferro-cerio inizialmente destinati ad innescare la fiamma su cannelli da saldatore. Con l’amico Alberto ne ricavava le allora quasi introvabili pietrine da accendino da spacciare dentro e fuori del lager, per il controvalore di una razione di pane cadauna: la vita assicurata per un giorno. Sempre una pietrina gli fu salvifica, quando incapace di intraprendere la marcia per Buchenwald e Mauthausen, fu abbandonato dai tedeschi in fuga nell’infermeria del campo. La sua baracca fu la prima e per un po’ anche l’unica ad avere una fioca luce ed il calore della stufa su cui cuocere rape scongelate e far sciogliere la neve per dissetarsi. L’aveva sottratta abilmente alla perquisizione e gli fu provvidenziale per accendere il fuoco strofinandola accanto ad un pezzo di carta imbevuto di alcool.
In un test di selezione per partecipare ad un concorso scientifico fra ragazzi di un istituto di Torino, ho inserito il quesito riguardante lo strumento salvifico utilizzato da Primo Levi, prima della liberazione dal campo di sterminio. Le opzioni erano: a) una bussola; b) una pistola con quatto proiettili; c) una trappola per topi; d) una pietrina da accendino. Su più di un centinaio di partecipanti, nessuno scelse l’ultima risposta, ritenendola fuorviante. Le motivazioni per le altre opzioni riguardavano la possibilità di orientarsi verso l’Italia dopo la guarigione, la difesa contro malintenzionati compagni di sventura e impedire ai roditori di rubargli il cibo. Per tutti fu inconcepibile una situazione di ritorno alle condizioni di prima della scoperta del fuoco!
Per finire questa lunga chiacchierata sulle pietre focaie, racconto dell’episodio cui ho assistito alla scuola dell’Abbadia di Stura dove c’è un locale previsto come camera oscura per la fotografia, ma che fu adibito a deposito di scope. Non attrezzato con l’apposita lampada a luce rossa per lo sviluppo fotografico, una volta azionato dall’interno l’interruttore, vi regnava un buio pressoché totale, appena intaccato dalla luminosità esterna filtrante da sotto la porta: luogo ideale per farci le scintille. Ci andavano in quattro alla volta, uscendone euforici. Quando venne il turno di una certa ragazzina, questa si oppose energicamente, adducendo come motivazione di essere allergica alla polvere. In verità sulla lastra su cui avveniva lo strofinamento si poteva vedere depositato un polverino finissimo. L’obiezione che lei fosse allergica sì agli acari della polvere di casa ma non a quella delle pietre focaie non la tranquillizzò per nulla e scappò esclamando: «La dottoressa non vuole!».
Le compagne, maliziosamente, le estorsero in seguito la verità, che cioè la sua era semplicemente paura del buio. Mal gliene incolse quando fu invitata ad una festa di compleanno: la padroncina di casa, in combutta con tutti, fece scattare l’interruttore generale, suscitando nella malcapitata vittima strilli di terrore panico per il buio piombato in tutte le stanze!