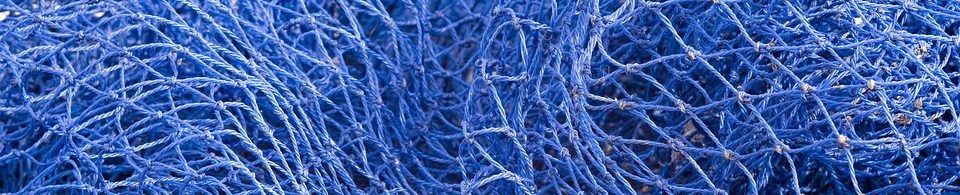LA VOCE IMPAZIENTE. VIAGGIO NELLA POESIA (28, 29, 30) di Grazia Valente
28. La parola è indomabile
Poiché la parola non sempre ci segue, spesso dobbiamo rincorrerla, catturarla, domarla. E a volte il risultato non è quello che avremmo voluto.
Seguo la traccia scura
il filo nero sul foglio
ingarbugliato
attorcigliato al rigo
incuneato tra le dita
come un ragno esasperato
davanti alla sua tela
non riuscita.
Anche la collaudata intelligenza del ragno può trovare ostacoli. Ma possibile che egli non sappia più tessere la sua tela? Quella tela che, catturando insetti, gli è necessaria per sopravvivere? Forse si può intravedere, in questa ribellione della tela nei confronti del suo tessitore, il rifiuto della poesia a irretire, vale a dire a ingannare. E quindi, se si tenta di farlo, la parola si fa confusa, contraddittoria. Non diventerà mai poesia. Non abbiamo risposta a queste domande. Quanto può sentirsi solo, il poeta!
29. La solitudine del poeta
Le voci dei poeti
sono lontane anni luce,
solitari meteoriti
alla ricerca delle stelle
perdute.
Il poeta è consapevole che il mondo al quale egli aspira è oggettivamente lontano. Non soltanto un particolare modello di mondo migliore, vale a dire di società, che – consapevolmente o meno – ha sempre ispirato l’artista. Il desiderio è soprattutto quello di una umanità migliore, poiché il poeta vede, addita, denuncia. E al suo realismo di veggente non sfugge l’amara considerazione che tale traguardo è collocabile ad anni-luce di distanza.
Ma l’immagine dei meteoriti, che vorrebbero ricongiungersi alle stelle d’origine, è anche la trasfigurazione lirica del desiderio del poeta di sentirsi parte di un tutto e non scagliato al pari di una scheggia nella solitudine cosmica. Infatti il poeta, più che bearsi della propria solitudine, (atteggiamento che gli conferirebbe quell’alone di romanticismo al quale invece è bene sottrarlo) la subisce, accettandola infine come inevitabile.
30. Il pessimismo del poeta
Si parla spesso di un pessimismo del poeta, in senso negativo.
La mia penna è intrisa
d’aurora
ma la mente è inseguita
da ombre notturne
fruscianti
su bianche pareti extra-strong.
Tutti vorremmo scrivere cose che suscitino speranza nel futuro, ma la mente raziocinante non sempre è condiscendente, poiché la poesia è, innanzitutto, verità, anche se si tratta di una verità carica di umanità e quindi che non vuole giudicare o condannare, ma illuminare. E se il poeta vuole restare fedele a tale principio non potrà sfuggire al gramsciano pessimismo della ragione che lo induce a fissare lo sguardo sulle cose che non vanno piuttosto che su quelle che, in qualche modo, offrono soluzioni. Quindi, se per ottimismo si intende, come spesso accade, nascondersi o minimizzare le difficoltà, allora certamente il poeta, che invece le difficoltà le vede, le soffre e le analizza, è un pessimista (1). Ma tutto questo alla fine ci sembra fuorviante.
(1) Diceva Sciascia: “Il vero pessimismo sarebbe di non scrivere più, di lasciare libero corso alla menzogna. Se non lo faccio, vuol dire, in definitiva, che sono inguaribilmente ottimista”.