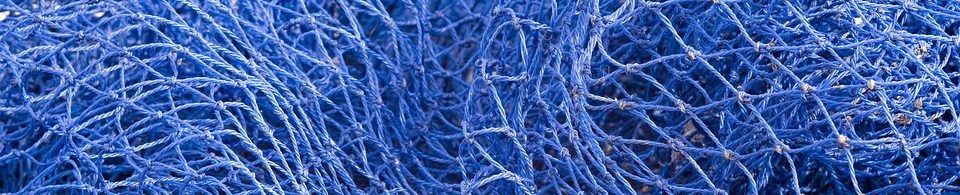PALESE STORIA DI SEGRETA RICETTA DI P. P. Roe (Pietro Paolo Capriolo)
Questo preambolo intende dichiarare un umile tentativo di emulazione. Nell’introduzione al suo romanzo, il Manzoni ricorre all’espediente del rinvenimento d’un manoscritto seicentesco. Egli stesso, prima di confessare di non volerne più fare la trascrizione preferendo il rifacimento nella lingua ottocentesca, si cimenta in un saggio di vetusta scrittura, con tanto di vocaboli desueti e scorrettezze grammaticali e sintattiche allora tollerate, ma che -dico io- perfino uno studentello dell’Ottocento avrebbe dovuto evitare quali gravissimi errori.
Sbagliare non è difficile ed un po’ d’eco di antica letteratura m’era rimasto dagli studi di filologia, così quando intrapresi l’opera in un fine settimana da neo pensionato, tra fantasia e divertimento, passai ore serene a scrivere in un linguaggio volutamente arcaico, con grammatica e lessico non ben definiti.
Lo stimolo m’era giunto dall’amica ed ex collega Marilù (sì, la stessa dell’ode anacreontica pubblicata tempo fa) solita a partecipare con la sua scolaresca a svariati concorsi, a volte vincendoli. Mi chiedeva aiuto per qualche variante di ricetta e/o curiosità storiche che riguardassero il minestrone.
La vicenda prende vita dalla presenza nella zona di una antica abbadia che, oltretutto, dà il nome alla scuola che insiste sul territorio, rispettando quindi le richieste del bando di concorso. Ai fini pratici, bastava anche meno, ma la faccenda era così intrigante…
Da la Cronica di ser Piero, abadiense scribacchin provetto
Storia de frati, briganti, pentoloni e… un cane.
Sol gli occhi spuntan fora a Toni Cartuné lo qual s’en vien da Torino ver lo borgo nostro. El freddo sì, ma di piue la nebbia l’avean vinto a serrar tabarro, calar berretta ‘n capo e si torcigliar longa pezza de lana al collo fin su ‘l viso.
Ne l’aia, retro la porta de ferrato legno, lo can de’ frati move passo nerboso, a scatti: fiuta l’aer denso de fumo e de novello odor sospetto. L’abate Prospero l’arìa poi ribattezzato “Infido” a lor che alfin tornossi, vergognosa coda celando fra le fangose zampe.
Tra pioppi e salici, a bordo de’ fosso, due figure impagliate con stracci e pezze déon parer òmini armati di schioppo e randel, in agguato de’ viandanti. Astuto remedio questo pensato da Cesco lo qual, per troppo denar perduto a i dadi, fu cacciato ier l’altro da la sua banda.
Questa la compagnia d’attor. Non femmina veruna ne la scena d’un natural teatro a la gran curva de l’Abadia de Stura, ne lo calato scuro e nebbia tanta.
Epperò, al ver, una v’è. La mula avanti al carro, al chiaror de fumentosa lampa, avanza sperando in cheta notturna sosta su paglia, con fien allato e biada alquanta.
Toni, el carraro, a la sua donna in vece pensa, al focolar intenta, e già si crede con ella pascer polenta e quattro fetton de lardo salso avuti in giunta a lo pattuito prezzo per lo trasporto in ora sì tarda.
Ma ecco che una de l’ombre in pié si vien a mezzo della via: la mula tosto s’arresta, ‘l carraro sbraita devota imprecazion a qualche santo.
Cesco armato avanza e «La borsa o la vita!» comanda.
Toni risponde «Denari no, fagiuoli e ceci ne son tanti…».
«Bestion, non banda de cochi, ma bravi in arme siamo. O tu mi dai l’ariento che teni o faccio zuppa de cristiano!» rimbotta Cesco e, per lui piue convincer, una schioppettata al cielo manda.
La bestia a l’aria scalcia, alza ‘l barroccio et a terra ‘l Toni pianta. Poi, con ‘l cor pien d’affanno strano, oltre ‘l fossato corre a lato de la cinta de l’Abadia, seminando sacchi, ceste, fagotti e, legati con spago, li pezzi de lardo anco.
El carraro, tra le nebbie, nota l’altre ombre con li schioppi ferme e mute e che ‘l bandito, per lo scanso de la mula, è caduto. Allor ver lo porton si lancia et intanto a la mula grida «Ferma, ferma, ché mi rovini…», ma de retro ode «Fermo o t’accoppo!» allor ancor piue s’affretta.
Latra da vicin el cane, s’odon passi oltre la porta. A questa batte disperato, ché lama di coltel sassino teme.
Al romor de lo schioppo e de la frequente et forte tambussata accorre non lo frate portinaro, ma l’abate ‘n persona, lo qual socchiude ma poi, al grido pietoso et a la spinta del Toni, spalanca l’uscio.
Fora ‘nvece se projecta ‘l cane, fiutando traccia di conciato porco, da la mula tratto per la corda longo ‘l muro et i sassi de la sterrata via.
La bestia l’altra bestia ‘nsegue, bramando manducar ghiotto boccon, epperò in tanto viepiù la impaùra sì che quella altro et altro fardel, li facendo cader a terra, lacera e sparge.
Entra ‘l carraro trafelato.
N’esce ‘l prior Prospero a la rapida cattura de ‘l can, correndo. Immantinente, poco oltre la soglia, scontrasi con un’ ombra, corpulenta ombra, de ruvido vestito e barba incolta adorna.
Qual gagliardo toro per stazza travolge lo vitellon più giovin suo fratello, tal lo reverendo corpo soverchia in panza et abbatte l’uom di banditesca razza.
Oh, qual ventura che fusse l’abate e non lo sagrestan, non fra Mignìn né fra Martino ché, en tre, non gonfierebber la vesta del priore!
Tramorto e tradotto da’ frati in picciol cella con parvola fenestra, Cesco quivi si sta fin al mezzodì, quando de gendarmi la truppa il trae per la preson condurlo.
Si manda a dire a la mogliera che ‘l Toni è salvo e tornerà postea aver recuperata la mula, ‘l carro e ‘l carco de vettovaglie per la campagna sparso.
Si va a la ricerca in ventidue: venti son li frati, l’abate e ‘l povero carraro.
Chi trova un sacco sfondato, chi un cesto rotto e chi un fagotto; chi la mula, chi ‘l carro sanza una ruota e chi la ruota sola; chi un pugno de ceci, chi le cipolle e chi l’ultimo fagiuolo.
El can no, non va alla cerca, ma vien cercato.
Tutto si raduna: tanta roba è guasta, calpesta, trita e sporca e niun la comprarìa.
A lato d’un fosso, si trova la cotenna con poco lardo a dosso, scampato a’ morsi de lo bastardel quadrupede ancor fuggiasco.
A la vista de tanto desastro, lagrime spuntan a l’occhi del povero cristiano: non ave di che ripagar el committente.
«Balordo ladron (va dicendo a voce alta) che sanza rubarme cosa alcuna m’ hai tu lo stesso rovinato. Che ‘l diavolo ti pigli!»
Ma lo dimonio in convento sol ne lo proverbio facile vita campa e che facci pentole sanza coperchio ogni fraticel sa e convinto lo va ripetendo a l’altri.
Qual formica o ape che picciol suo bottino porta e tutte insiem fan scorta granda, tal voce repetuta rimbomba a l’orecchio santo de l’abate ch’ è pio e devoto anco de l’arte cucinaria.
Inspirato, dunque sentenzia: «Ma noi pentole e pignatte tutte con lo coperchio avemo né ci mancan padelle e gran marmitte».
(Bada lettor: “pignatte” e “marmitte” scrissi. Non pensar a le mignotte como profetico sentor mi fa, fra secoli, intra veder sostare ne’ paraggi!).
D’un carro de vivande ciancicate, con la giunta de cavoli, agli, carote et altre verdure de l’orto de’ frati, el poco lardo e sale, ne ven fora in tre ore zuppa tanta ch’a divorarla l’appetito de’ frati non basta.
Per far fruttar la ritrovanza de lo periglio scorso, a consolazion e recompensa de lo sfortunato Toni, ne van col carro in procession pel borgo a vender la menestra, un soldo a mestolone, et una benedizion de vino rosso.
Generoso la trae fumante ‘l Prospero prior da’ pentoloni e va, fra il riso, predicando: «A figlioli vostri date la menestra santa de lo convento mio. Al par di me, crescer li fa forzuti e grossi».
A tanto model, lieta volentier la gente compra e spera, per la menestra che li frati van spacciando, ch’ogni piccin fustacchion si faccia.
Che de sugestion se tratti o per la benevola mistura non ti so dir, però si dà per certo che i fantolin, sempre mangiandola sera e matina, si crescon robustosi e forti.
Adunque, caro lettor, sappi che per ciò non piue sol menestra, ma menestron da quel dì in tutt’Italia la novella ricetta è detta.