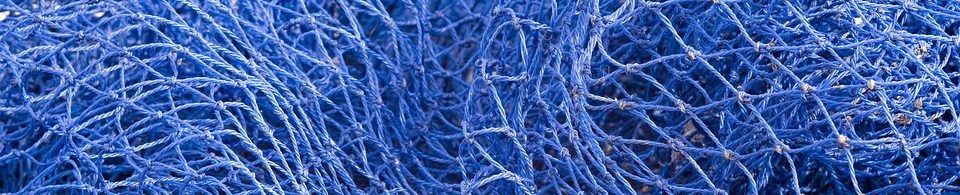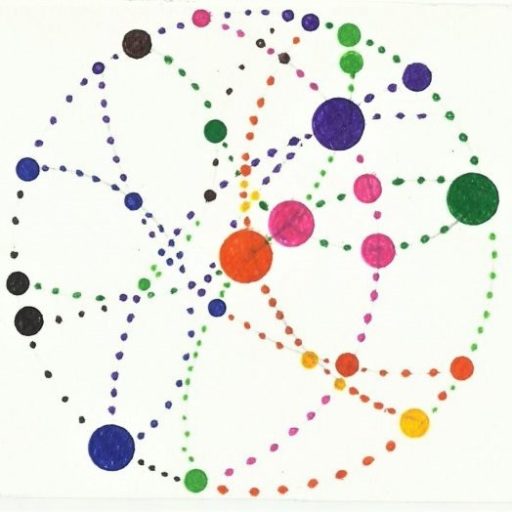TROPPA GRAZIA, SANT’ANTONIO! di P. P. Roe (Pietro Paolo Capriolo)
Questo simpatico e proverbiale detto prende spunto dalla disavventura in cui incorse un uomo di piccola statura che non riusciva a montare a cavallo. Dopo vari tentativi, si raccomandò al suo protettore celeste e pieno di ardimentosa fiducia spiccò un salto tale che gli fece oltrepassare il dorso del quadrupede. Ritrovatosi a terra, avrebbe così bonariamente fatto le sue rimostranze.
Applico questo aneddoto alla sovrabbondanza di anidride carbonica presente sul nostro pianeta. Oggi questo gas gode di cattiva fama, perché lo si addita come una delle principali cause dell’innalzamento della temperatura, ma è tutto questione di proporzioni e di tempo: non sempre fu così. Quando il pianeta stava per ospitare la vita, fu anche la sua presenza a permettere quel buon effetto serra (ora eccesivo) per trattenere il calore ed impedire che tutta l’acqua ghiacciasse e, in altre ere, permise la crescita di enormi foreste poi fossilizzate.
Il biossido di carbonio inoltre è alla base della vita. Tutti gli organismi viventi traggono esistenza e sostanza organica indirettamente o direttamente dall’anidride carbonica che, grazie alla fotosintesi clorofilliana, per sei delle sue molecole ne fornisce una di glucosio che è il più importante prodotto della scissione. Questo carboidrato semplice viene utilizzato in parte per le necessità vitali delle stesse piante, ma anche immagazzinato sotto forma di cellulosa ed amido. Come tutti sanno, nel processo viene liberato anche l’ossigeno, elemento indispensabile alla nostra vita per bruciare le calorie e ricombinare CO2.
Ad un primo impatto, pare abbia trascurato di coinvolgere degnamente l’acqua e la luce del sole, ma è solo perché ho voluto assumere per un po’ le parti dell’avvocato del diavolo difendendo l’imputata. Ristabiliamo le giuste prerogative: ben dodici atomi di idrogeno sono forniti dall’acqua ed altrettanti dodici di ossigeno vengono “scartati” nell’atmosfera. Il carbonio invece resta tutto prigioniero nella nuova molecola ( C6H12O6) prodotta dalla clorofilla sfruttando l’energia della luce del Sole. Quando si dice che la vita sulla Terra è basata sul ciclo del carbonio, qualcuno può essere indotto ad immaginare qualcosa di solido e nero, come la grafite d’una matita, invece l’aspetto con cui si presenta quale cibo per essere letteralmente “mangiato” dalle piante è quello gassoso e volatile prodotto con rombo di tuono dai vulcani, ma anche espirato dalle labbra di un bimbo nella culla, scambiato nell’effluvio dolce di un bacio o vibrante in un ruggito ferino.
Negli esseri viventi è una continua alternanza di uscita sotto forma di CO2 ed entrata con l’aspetto tangibile di materia: dal Krill quale nutrimento delle possenti megattere al dolce miele dell’alveare, dalla gustosa bistecca per il rude cow boy all’insalatina scondita per le signorinelle attente alla linea. Ciò che non è subito fruito, va a costituire massa corporea per lo stesso essere vivente o altro consumatore. Questo utilizzatore può essere vicino nello spazio e nel tempo come il ranocchio che balza sull’insetto nello stagno o lontanissimo geograficamente ed addirittura in altra era geologica come il pilota di Formula 1 che a Monza fa rombare il motore con il propellente estratto magari dal sottosuolo dell’Arabia.
Già, con questo esempio ho introdotto una carburazione artificiale, non dovuta al ciclo evolutivo della vita, ma a quello dell’attività umana, di quella che si svolge prevalentemente nell’era che il Nobel Paul Crutzen nel 2000 chiamò Antropocene, epoca nella quale il suo protagonista, l’uomo, può trasformarsi facilmente in fattore d’autoestinzione. La data d’inizio dell’Antropocene è fissata convenzionalmente a partire dal 1945, infatti l’homo sapiens, prima della grande rivoluzione industriale, s’era limitato a reimmettere nell’atmosfera quantità di anidride carbonica tutto sommato ben compensate dalla natura; poi la fame di energia aumentò in maniera esponenziale e si intensificò lo sfruttamento delle riserve fossili del sottosuolo.
Scoprendo il fuoco, fin dalla preistoria, l’uomo lo aveva utilizzato per impieghi culinari, artigianali (ceramiche e lavorazione dei metalli), strategico-militari, ma soprattutto per l’illuminazione ed il riscaldamento le cui tecniche per millenni sono variate di poco. Non sto a parlare della voracità dei consumi e conseguentemente dell’aumento della CO2 in conseguenza delle industrie, della produzione dell’elettricità e del riscaldamento delle città moderne, mi limiterò a riandare a tempi nemmeno troppo lontani in cui il tepore delle case e l’illuminazione erano molto contenuti, rievocando esperienze dirette e/o di comune sentore.
Ancora nei primi decenni del secolo scorso, candele, lampade a petrolio o a gas di città erano diffuse ovunque, come ben possiamo constatare dall’ambientazione di film in epoche passate. Ci paiono situazioni talmente lontane dalle nostre abitudini che quasi stentiamo a crederci, ma nel concreto vivere quotidiano era davvero così. Un mio nuovo compagno di scuola, vedendo la maestra accendere le lampade dell’aula agendo semplicemente sull’interruttore elettrico, le domandò se non avesse paura di bruciarsi. Evidentemente la sua esperienza di illuminazione, già negli anni ’50, era ancora legata alla fiamma ed alle precauzioni che gli erano state inculcate. Raccontando poi il fatto alla mia mamma, lei mi confidò esperienze di quando era bambina nella Torino dei primi anni trenta, dove la sua casa era servita dalle tubazioni del gas illuminante. Riandando alla stregua delle sue parole, immagino il nonno ergersi ad armeggiare con la valvola ed il paralume riflettente, accendere la fiammella e sovrapporle una reticella con la funzione di meglio diffonderla e potenziarla con qualche preparato che ne rendesse più bianca la luce. (Gli studenti del Campus Einaudi di Torino possono scorgere nell’area Vanchiglia le vestigia volutamente conservate dell’antico gasometro dove veniva stoccato il gas prodotto per arroventamento del carbone litantrace, purificato e poi diffuso in città. Difficilmente da quella vista possono immaginarsi le condizioni di vita d’allora). Gli ambienti si impregnavano dell’odore della combustione del gas o del petrolio dei lumi portatili, soprattutto nei paesi nordici dove non era disponibile l’olio d’oliva cosiddetto “lampante” e, chi poteva permetterselo, acquistava l’olio che emanava un vago odore di cucina e che proveniva dalle scorribande delle baleniere a caccia di capodogli.
La casa della mia infanzia era dotata di luce elettrica in tutti gli ambienti, ma non aveva ancora i termosifoni. Con il fratello maggiore, da bambino, ho sistemato sotto la tettoia grandi quantità di ceppi e tronchetti di legno per alimentare la cucina economica (detta anche potagé) che serviva a riscaldare l’ambiente, a cucinare e garantire una riserva d’acqua calda nell’apposita caldaia accanto allo sfiato dei fumi. In tutto quell’edificio, ogni famiglia aveva una sola stanza riscaldata, appunto la cucina, dove oltre alle pratiche gastronomiche si faceva un po’ di tutto: dal bucato, ai compiti di scuola; faceva eccezione l’alloggio degli zii di cui dirò fra poco. Le altre stanze, d’inverno, erano gelide e venivano praticamente utilizzate solo per dormirci, dopo aver intiepidito le lenzuola, con lo scaldino metallico ripieno di tizzoni ardenti, o con una borsa d’acqua bollente o addirittura con un mattone non traforato estratto con le molle dal forno, avvolto in un sacchetto di stoffa e posto sotto le coltri in fondo ai piedi.
Nel cortile, dove i fornitori scaricavano la legna, entrava anche l’automezzo carico di trucioli e segatura, materiale non omogeneo che veniva ammonticchiato con un badile da mugnaio in un capace sottoscala fino al soffitto. Per me e la mia cugina era un’occasione di gioco nelle giornate di pioggia: ci tuffavamo letteralmente dentro, come il vecchio zio Paperone nel suo deposito di monete d’oro! Prima di ripresentarci nelle rispettive case bisognava darsi una bella ripulita da uno sporco tutto sommato ecologico al 100%. Il suo papà, da ex fabbro, s’era costruita una stufa di lamiera a doppia camera. Quella interna, detta anima o camicia (perché la si sfilava ogni giorno), veniva riempita di trucioli e segatura, badando a pressare bene il combustibile aggiunto poco alla volta in strati intorno ad una specie di mattarello che al momento dell’uso veniva estratto, lasciando un foro verticale alto anche mezzo metro. Le lamiere, interna ed esterna, avevano entrambe un’apertura che dovevano collimare e l’esterna era dotata di uno sportellino traforato per far passare l’aria. Un tubo, o cannone da stufa, provvedeva a smaltire i fumi all’esterno, partendo da sotto un grande coperchio. Queste stufe avevano il pregio di consumare scarti di lavorazione e di scaldare per una notte intera, non producendo una vera e propria fiamma come nel caminetto, ma sfruttando una combustione lenta, quasi da enorme braciere di trenta chilogrammi. Lo zio alla sera portava su nel suo alloggio una camicia carica, la stessa che poi noi bambini al mattino, prima di andare a scuola, avremmo rivisto vuota e con qualche spirale di fumo residuo, presso l’orto dove sarebbero state sparse le ceneri a fertilizzare la terra. Mio papà invece diffidava di queste stufe, perché ogni tanto si sentiva la notizia che era morto qualcuno per l’emissione di monossido di carbonio (CO), causato dal tiraggio o dalla carica della camicia non proprio alla perfezione. D’altra parte, la famiglia di mia cugina conviveva con i nonni paterni e là cucinavano e si scaldavano di giorno e a loro andava bene così.
Non è pericoloso solo il monossido, perché velenoso (se ne servono per abbattere gli animali da pelliccia), ma anche la più innocua anidride carbonica, da sola, uccide. Ogni anno leggiamo di incaute persone che soffocano in cantina dove, per dirla con il Carducci, «dal ribollir de’ tini» il gas si sprigiona e ristagna in basso, come nella Grotta del Cane dei Campi Flegrei, un tempo meta di dimostrazioni scientifiche “in corpore vili”, cioè su animali di piccola taglia costretti a respirarlo, mentre le bocche degli spettatori erano ad un livello più alto in presenza dell’ossigeno. Ciò avviene non solo in cantine non arieggiate, ma anche in vasche e depositi di sementi dove si sia svolta una fermentazione e/o germogliatura imprevista. Nella mia attività di insegnante di laboratorio di scienze, ho compiuto innumerevoli sessioni di esperimenti con la CO2CO2, non limitandomi a commentare la pericolosità insita nella notizia. Con l’irrisoria spesa di un po’ di aceto e di bicarbonato di sodio, il riciclo di barattoli di vetro e moccoli di candela, si possono fare attraenti ed indimenticabili dimostrazioni che potrebbero anche salvare la vita. Ne voglio descrivere una, svolta con duplice finalità: evidenziare che la CO2 è più pesante della miscela d’aria che respiriamo e che non permette la combustione.
Sui due piatti di una bilancia a bilico (che ci si può procurare anche con salutare bricolage) si pongono identici bicchieri trasparenti. Con qualche granello di sabbia collocato accanto al più leggero, si fa in modo che l’equilibrio sia perfetto. Se i bracci sono lunghi, ci vuole tempo e pazienza, ma l’esperimento riesce meglio. Una cucchiaiata di bicarbonato di sodio in fondo ad un barattolo alto o in una brocca viene fatto reagire con un bicchierino di aceto economico. Passata la schiuma, si può travasare con cautela la CO2in uno dei bicchieri sulla bilancia che comincerà ad inclinarsi. Idem versandola in un barattolo sul cui fondo è stata deposta, mediante filo di ferro attorcigliato intorno, una candelina accesa: la fiamma si spegne subito. Bella e divertente la variante che -chissà perché- abbiamo chiamato della “Candela impiccata”, cioè l’immersione lenta, sempre con l’ausilio di filo di metallo sagomato, di un lumino o moccolo di candela in un capace barattolo con sul fondo l’anidride carbonica, cercando “sadicamente” di far morire la fiamma solo dopo ripetuti tentativi di rianimazione alzandola quel tanto che bastava perché potesse ossigenarsi. Sono esperimenti molto coinvolgenti che i ragazzi non dimenticheranno più. Va fatto ovviamente notare che, scendendo in cantina, la candela accesa va tenuta all’altezza della cintura per avere modo di risalire in tempo la scala, se quella dà segni di spegnimento.
La curiosa notizia di quest’estate è che scarseggia l’acqua minerale frizzante. Con tutta la CO2 in sovrabbondanza, non ce n’è però a sufficienza di pronta all’uso per essere addizionata all’acqua. La differenza con la birra e certi vini che invece ce l’hanno è dovuta all’autoproduzione da parte dei lieviti loro componenti. La difficoltà di reperimento è causata dall’aumento del costo dell’energia e di trasposto. Produrla direttamente come faccio io, o con distillazione frazionata dell’aria, costa molto di più che ricavarla come sottoprodotto di altre produzioni, per esempio dei fertilizzanti. Il conflitto Russia – Ucraina influisce anche in questo settore; i fornitori preferiscono destinarla ad altri comparti, come quelli della sanità, della sicurezza (estintori) e della conservazione degli alimenti in atmosfera modificata. Pare che l’Italia sia il paese con maggior consumo di acqua minerale gassata e non pochi si troveranno a disagio. Dite che è il caso che si rivolgano a sant’Antonio?