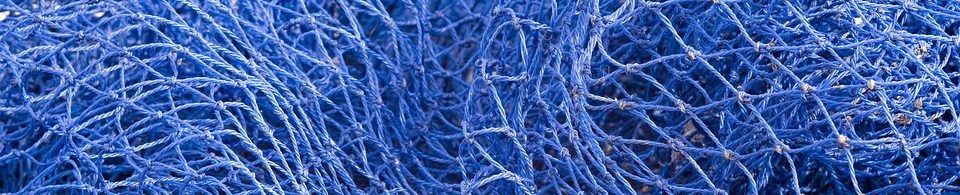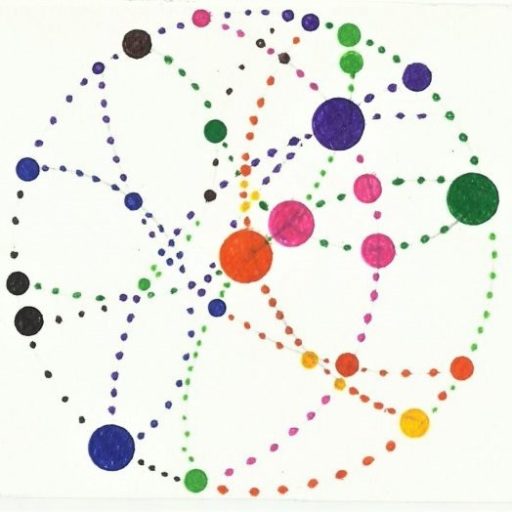INVENZIONI E SCOPERTE EVOCATIVE di P.P. Roe (Pietro Paolo Capriolo)
Paiono lontanissimi i tempi in cui potevo fare una settimanale e fugace chiamata a casa dal telefono a gettoni della caserma o una un po’ più lunga dalle postazioni dei Telefoni di Stato della stazione Termini, in libera uscita. Sono passate solo poche decine d’anni, ma una situazione del genere nei giovani d’oggi ingenererebbe una crisi di deprivazione, una vera sindrome di astinenza da smartphone con effetti psicosomatici che il buon Antonio Meucci proprio non si sarebbe sognato di suscitare inconsapevolmente. Quando alziamo la cornetta (e ce ne sono ormai poche) o sfioriamo con il dito uno schermo attivo touch screen dei nostri dispositivi portatili, in quanti ci ricordiamo del vecchio italico inventore?
La radio, dalle cui onde siamo avvolti in casa come in auto, siamo proprio sicuri che tutti la sappiano ricollegare al bolognese Guglielmo Marconi? Mi rivedo bambino negli anni cinquanta ad ascoltare la sera, prima di cena, il giornale radio con la famiglia riunita per questo quotidiano rito. Il papà, che da militare era stato addetto alla radio, a volte mi diceva: «C’è Marconi qui dentro!» alludendo certamente alla scoperta che consentiva la trasmissione, ma non escludo che un po’ mi prendesse in giro e, stando al suo gioco, gli obiettavo che la voce non era sempre la stessa e che ne scaturissero anche di donna ed inoltre note musicali.
La parola voltaggio e le scritte 12 – 24 – 220 V. ecc… che compaiono su apparecchi, trasformatori, carica-batterie… ci ricordano Alessandro Volta, inventore del generatore statico di corrente elettrica che, prima d’avere il nome a noi ben noto, venne annoverato come “apparato scotente (= scottante) artificiale” e poi “organo elettrico artificiale” (paragonato alla capacità di stordire le prede del pesce torpedine) ed infine pila. Mi punge vaghezza di fare in proposito alcune digressioni, cominciando dal nome.
Nel dialetto romanesco, mettere un pollo nella pila significa cucinarlo in una pentola/casseruola ed il termine pila, in italiano, mantiene il significato di contenitore anche in altri contesti, ad esempio l’acquasantiera (con riferimento al recipiente e non alla colonnina su cui può poggiare in talune chiese) o anche i grandi mortai per il riso pilato, cioè sbramato della lolla o pula che non riusciremmo a digerire per l’alto contenuto di silicio. Per inciso, il riso pilaf invece è una ricetta di derivazione turca per accompagnare carne, pesce e verdure. Una pila di libri, vale a dire diversi volumi incolonnati uno sull’altro, è l’immagine che dobbiamo avere per riferirci all’espediente di Volta che semplificò il suo precedente metodo di produrre elettricità dalle coppie bimetalliche immerse nel liquido di tanti barattoli (modello detto “a corona di tazze”) con gli elementi rame e zinco alternati. Incolonnando tanti dischi di rame e di zinco separati da altri di feltro, tutti tenuti insieme e pressati da un torchietto, si aveva a disposizione la pila che al momento dell’utilizzo veniva irrorata di acqua acidulata; questa, impregnando i dischi di feltro, dava inizio alla reazione. Dall’elemento in alto e da quello in basso partivano due fili conduttori. Si sente ancora dire “pile a secco” che sono quelle che tuttora acquistiamo ben sigillate e che emettono brodaglia pericolosa solo quando sono molto vecchie e possono danneggiare gli apparecchi in cui sono inserite. La pila a corona di tazze è quella che più si presta per gli esperimenti a scuola. Escludendo l’acido solforico, si può ricorrere ad aceto, succo di limone, soluzioni con sale o zucchero, bevande varie… e posso garantire che funziona anche con la pipì! Con le lampadine a filamento, gran parte dell’energia viene consumata nell’arroventare il filo di tungsteno e, pur ricorrendo a lampadine mignon, l’effetto è di breve durata anche con molti barattoli in parallelo ed in serie. Ora ne possono bastare quattro o cinque per illuminare i led che si recuperano da spie luminose o molto più comodamente da esaurite lampade votive per cimiteri che sono in vendita accanto ai lumini a cera, ma queste con due pile da 1,5 V. restano accese anche un mese (Basterebbe sostituire le batterie, ma spesso tanta gente le butta via). Quando non era così facile reperire led a basso consumo, ho utilizzato un orologino a cristalli liquidi, inserendo fili di rame e lamelle di zinco in pezzi di patata. A questo punto è legittima la domanda di tanti ragazzini: se ai suoi tempi ancora non c’erano le lampadine, i led, gli orologi a cristalli liquidi, i motori elettrici… come faceva A. Volta a dimostrare il funzionamento della sua invenzione? L’arcano un po’ lo svela l’antica denominazione: si producevano scintille come quelle generate da macchine che per attrito catturavano l’elettricità statica o, se si era coraggiosi, accostando la lingua alle estremità dei conduttori si poteva percepire una scossa. Ma si poteva dare la scossa a Napoleone? Da anni già era in uso uno strumento che abbinato al condensatore dimostrava che corpi carichi di elettricità della medesima polarità si respingono come i magneti. L’elettroscopio a foglie d’oro è rappresentato nei quadri ed illustrazioni che ricordano il famoso esperimento alla presenza del Primo Console. Questi, non dimentichiamolo, aveva seguito con successo le lezioni di matematica e fisica all’accademia militare e subito intuì la valenza dell’invenzione di Volta, tanto da decretare, ipso facto, che fosse degno d’essere premiato con medaglia d’oro.
Per bizzarro accostamento di idee, la lingua ed il riconoscimento del merito con una premiazione mi dispongono a parlare di un altro inventore italiano cui tuttora l’umanità deve molto. Mi riferisco ad Ascanio Sobrero di Casale Monferrato in provincia di Alessandria, insigne medico e chimico, noto ai più per aver prodotto l’instabile ed esplosiva nitroglicerina. Ancor oggi la somministrazione sottolinguale di questa sostanza, o attraverso la pelle con appositi cerotti impregnati, salva e stabilizza la vita a tante persone con gravi problemi cardiaci. La nitroglicerina pericolosa da maneggiare e trasportare è l’ingrediente base dei candelotti di dinamite nei quali Alfred Nobel riuscì ad addomesticarla per scopi puramente esplodenti. L’industriale filantropo, al cui nome sono legati gli ambiti premi previsti dal suo lascito testamentario, volle però assolvere di persona il suo obbligo di riconoscenza nei confronti di Sobrero, assegnandogli un vitalizio , non tanto per i presupposti della sua scoperta applicata al campo minerario e militare, ma proprio per i meriti clinico-farmaceutici perseguiti.
Da appassionato di bricolage, mi capita spesso di ricorrere a quel particolare utensile costituito da un prisma metallico a sezione esagonale piegato ad elle chiamato semplicemente “chiave a brugola” per allentare o serrare particolari viti o bulloni che hanno nella testa non un semplice taglio o una croce, ma un incavo ad esagono. Si usa in lavori che richiedono maggior precisione o anche per scoraggiare ad esempio i vandali nella manomissione delle panchine del parco usando una moneta o un coltellino. La chiave, potendo essere maneggiata come una leva, permette un serraggio più robusto di quello fornito da un semplice cacciavite. Nel mondo anglosassone, ma anche nei paesi di lingua spagnola e francofoni, è detta chiave Allen, dallo statunitense W. Allen che l’inventò nel 1911. Invece, in Germania, con la consueta mania di precisione terminologica che li distingue (Innsensechskantshraube Bauer Und Schaurte = chiave ad inserto esagonale della ditta B. e S.), i tedeschi dovettero poi coniare l’acronimo INBUS (con N oppure M, indifferentemente). Ma ve lo immaginate il meccanico che chiede all’assistente di porgergli l’utensile con tutta quella sequela di nomi per indicare il tipo di strumento che gli occorre? Il nome italiano brugola deriva dal cognome di Egidio Brugola delle omologhe officine di Lissone in Lombardia che ne cominciò la produzione nel 1926. Il nome piacque subito, forse perché, terminando con la a, sembrava accordarsi bene sia con la vite e sia con l’apposita chiave.
Mi vengono in mente altri strumenti ed invenzioni attribuiti al genio italico, come il pianoforte (o meglio, il forte-piano) del padovano Bartolomeo Cristofori alla corte di Ferdinando de’ Medici nel 1700. No, con il pianoforte non ho dimestichezza, ma ho ugualmente un episodio da raccontare in proposito.
Nella chiesetta sconsacrata di san Pietro in Vincoli a Settimo Torinese era finito, chissà dopo quali peripezie, un pianoforte a mezza coda. Era stato confinato proprio là, forse perché vi si trovavano i membri del corpo bandistico cittadino per le loro prove. Una quarantina di anni fa, nella città dormitorio alla periferia del capoluogo piemontese era sorta l’associazione culturale Amici della Musica che, avuto notizia di quello strumento inutilizzato, decise di dargli una nuova vita. Dopo una perizia che decretò di non intervenire sulla “carrozzeria” esterna a dimostrazione della relativa vetustà, si optò per la sistemazione dei meccanismi interni e di farlo accordare a dovere. La millenaria pieve ospitò poi eventi culturali di vario genere: concerti, ma anche mostre, conferenze, esposizioni di quadri… Il pianoforte non poteva sempre occupare la parte centrale del piccolo presbiterio. Spostarlo non era facile, perché le rotelline di legno su cui poggiavano le gambe s’erano completamente consumate e trascinarlo sui lastroni di pietra non levigata comportava frequenti interventi di accordatura. Non trovandosi economici ricambi originali o compatibili, si optò per togliergliele del tutto e fissarlo su una pedana mobile, con sotto, diverse coppie di ruote di gomma pivotanti, fissate direttamente sui longheroni di acciaio che tenevano unite le assi. Il fabbro che ci aveva regalato l’intelaiatura, aveva sì praticato i fori ma, avendo in mente un sistema con inestetici bulloni passanti e dadi a vista, non li aveva filettati. Piero Aragno, socio fondatore, vice presidente dell’associazione, nonché abile artigiano sentenziò non essere inconveniente grave e che si sarebbe rimediato in una mezzoretta: egli avrebbe procurato le viti adatte e una maschiatrice per filettare i fori, cosicché l’indomani l’accordatore avrebbe trovato il pianoforte sistemato e fissato sulla sua pedana mobile. Ci diede appuntamento per dopocena. Tra i convenuti, l’unico ad essere pratico di quell’attrezzo era appunto il già citato Piero che, inginocchiato, cominciò a lavorare di lena. In un momento di pausa, essendo io il più giovane e desideroso di cimentarmi con quell’attrezzo, mi proposi per il cambio. Il lavoro procedette bene per un po’ fra i commenti degli altri che, notando come mettessi la lingua fuori dai denti per lo sforzo, mi canzonavano. Girando quell’attrezzo simile ad un cavatappi, alle loro risate mi distrassi e lo inclinai, spezzando l’inserto temprato. Mortificato, non avevo che parole di scuse fra i commenti sulla mia maldestra capacità manuale da parte di chi però non si era cimentato nel lavoro. Dopo averli lasciati sfogare, il previdente Piero con un gesto teatrale estrasse dalla tasca un altro maschio ed il lavoro poté essere completato. Il giorno dopo mi presentai alla sua bottega con una scatoletta appena comprata in ferramenta contenente tre punte come quella spezzata. Meravigliato, mi accolse esclamando «Chi rompe paga!» poi, aprendo un cassetto per riporvela, mi fece notare quante ne avesse già e che, comunque, apprezzava il gesto riparatore.
Potrei continuare con successi made in Italy, a partire dal pendolo di Galileo, per giungere alla lampadina del piemontese Alessandro Cruto di miglior efficienza di quella di Edison, alla vasca Jacuzzi ideata per alleviare i dolori di un componente della loro dinastia, alle reclamizzatissime bacinelle in Moplen (propilene di Giulio Natta, premio Nobel per la chimica nel 1963), alla Moka di Alfonso Bialetti che rivoluzionò il modo casalingo di preparare il caffè… Se c’è però una cosa che mi intriga molto è il sifone.
Di per sé il sifone esiste in natura e ben lo sanno gli speleologi che affrontano ambienti con acqua. Da tempo immemorabile è utilizzato per travasi di liquidi, ma la sua artificiale diffusione nelle nostre abitazioni è dovuta alla capacità di funzionare come tappo liquido: l’acqua ferma in una curva ad U o in un pozzetto impedisce ai miasmi delle fognature di invadere le stanze. Ritorno volentieri con la memoria a quella mattina degli anni novanta, quando da insegnante distaccato su laboratorio di scienze, scatenai una scolaresca alla ricerca e descrizione dei sifoni a vista nell’edificio. Ogni lavello fu visitato, da quello del cortile, alle batterie nelle sale igieniche degli alunni, senza farsi sfuggire quelli nei bagni di bidelli e maestre, le quali, stizzite, mi chiesero se fossi impazzito. Quando i bambini tornarono con disegni ed appunti, erano euforici per aver svolto una “vera” ricerca che dava sostanzialmente due risultati importanti sulla scelta d’installazione di un modello piuttosto che di un altro. Sotto i lavandini usati dagli adulti il sifone era costituito da un semplice tubo di piombo o di plastica curvato a collo d’oca, mentre dove si lavavano le stoviglie e nei bagni degli alunni avevano una forma a pozzetto con ghiera svitabile. Una semplice intervista al custode e factotum della scuola rivelò che questi si potevano così facilmente smontare per estrarre avanzi di cibo, tappi di dentifricio, cappucci e cartucce di stilografiche… I successivi esperimenti con acqua colorata, barattoli, cannucce, ma soprattutto tubi di gomma trasparente (acquistati in enoteca, ferramenta o recuperati da fleboclisi) sono stati entusiasmanti, dando origine anche a dinamiche di gruppo e di coppia per la collaborazione. Significativa, perché a portata di bambino, la spiegazione della risalita dell’acqua su per un tubo piegato ad U rovesciata che da un estremo pesca in una bottiglietta e dall’altro scarica in una bottiglietta posta più in basso: «Bisogna convincere l’acqua a salire, con la promessa di scendere poi ancora più giù»!
In quanti di noi non abbiamo assistito a scene simili osservando in cantina il nonno o il papà travasare il vino dalla damigiana nelle bottiglie? I verbi promettere e convincere –è vero– non fanno parte della terminologia scientifica, ma denotano un genuino approccio alla fenomenologia con bagaglio esperienziale infantile applicato al tentativo di darsi una spiegazione. Poi arriveranno le regole, le definizioni, le misure e tutto ciò che fa dell’ingenuo osservatore di oggi il futuro paludato scienziato di domani.
Ma ritornando al mio interesse per il sifone in sé, non mi risulta una attribuzione certa ad un noto personaggio scientifico, piuttosto si sa che il water a seduta (già rudimentalmente presente nella Roma imperiale ed in Cina, con acqua corrente) fu ideato da John Harrington figlioccio della regina Elisabetta d’Inghilterra sul finire del 1500, ma aveva l’inconveniente di non bloccare gli odori, per cui si tornò presto al pitale ed alla servitù addetta. Solo due secoli dopo se ne riprese l’idea grazie all’applicazione di un sifone nel tubo di scarico piegato ad S orizzontale ad opera dello scozzese Alexander Cummings, di professione orologiaio e costruttore di organi per le chiese. Eh, quando si dice che la sosta in bagno può avere momenti mistici..!
Alla corporazione degli idraulici è dovuta la diffusione dei sifoni in ogni casa e ad essi si dovrebbe assegnare un collettivo, benché improbabile, premio Nobel per l’igiene.